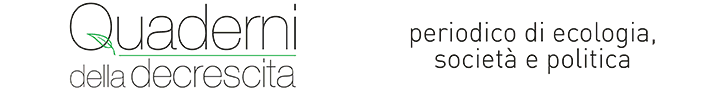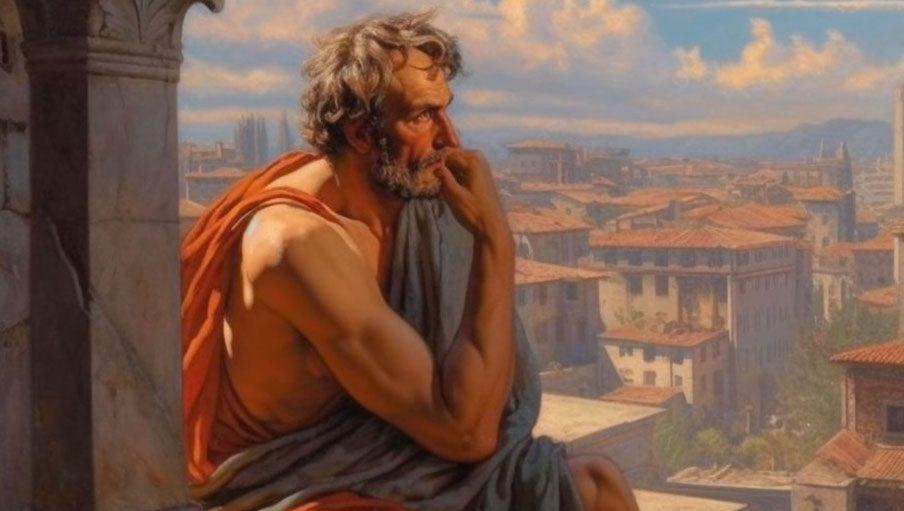
Tra Innovazione e Antimodernismo: una prospettiva stoica sulla decrescita
Di Luigi Oddo
Quando si cerca di trarre insegnamenti dal nostro passato, bisogna sempre tenere presente che il passato era immerso (o, per dirla alla Polanyi, “embedded/incorporato”) in un contesto sociale, politico, culturale e materiale estremamente diverso da quello attuale. Pertanto, ogni confronto deve essere valutato in base a questo principio, e più ci si spinge indietro nel tempo, più questa regola diventa valida.
Il mondo antico, in particolare quello greco-romano, non fa eccezione. Tuttavia, adottare una posizione eccessivamente “primitivista” nel senso finlayano o “sostanzialista” se si fa riferimento a uno dei punti di riferimento intellettuali dello stesso Moses Finley, ovvero Karl Polanyi, risulta comunque errato. Il dibattito sull’attualità del mondo antico, e quindi dei suoi lasciti culturali, dura da secoli, dai filosofi del XVIII secolo alla diatriba Bucher-Meyer di fine Ottocento, in cui il primo paragonava Roma alle società capitalistiche del suo tempo e il secondo le immaginava al livello di un’economia domestica primitiva. Successivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il professore di Yale di origini sovietiche in fuga dal regime stalinista, Michail Rostovtzeff, arrivò a paragonare l’ordine equestre romano alla moderna borghesia. Questo fu probabilmente l’apice della posizione modernista riguardo al mondo antico. Successivamente, come accennato sopra, l’arrivo di Karl Polanyi e successivamente di Moses Finley a metà degli anni Settanta segnò l’inizio di un’ortodossia primitivista che relegò nuovamente il mondo greco-romano a un contesto primitivo dominato dallo status sociale, in contrapposizione alla razionalità economica. Secondo questa prospettiva, il mondo antico era caratterizzato da capitali soggetti a una serie di norme socio-culturali, come l’evergetismo e il dono, e non era in grado di sviluppare una razionalità economica moderna o di manifestare una qualche forma di mercato o orientamento al profitto.
L’ortodossia primitivista durò per quasi vent’anni, fino all’alba del terzo millennio, quando alla luce di ciò che sarebbe stata definita la Nuova Economia Archeologica e dell’affermazione del neoinstituzionalismo anche tra gli studiosi dell’antichità, furono fatte scoperte archeologiche che dimostrarono che il mondo antico non era affatto statico. Questo naturalmente non significa che il mondo degli antichi fosse paragonabile alla nostra onnipresente economia di mercato; ad esempio, l’economia romana era scarsa in termini di capitali anche rispetto alle economie preindustriali del XVII secolo. Inoltre, il concetto di proprietà privata nell’antica Roma era sostanzialmente diverso da quello moderno, includendo anche il possesso di altri essere umani, gli schiavi. Tuttavia, nonostante le differenze regionali e a dispetto di ciò che alcuni non specialisti pensano, i mercati e l’imprenditorialità contavano nell’antica Roma, così come contava la redistribuzione, l’autoconsumo e il dono, formando una sorta di mosaico economico flessibile e probabilmente efficiente. In conclusione, è fondamentale evitare posizioni dogmatiche estreme—siano esse primitiviste o moderniste—per comprendere la complessità e la ricchezza delle economie antiche.
Alla luce di tutta questa storia, per quanto sia stata estremamente sintetizzata e forse anche banalizzata, e tenendo conto che potrebbe essere smentita nei prossimi decenni, mi sento di affermare che, con tutte le dovute cautele, la cultura antica può insegnarci qualcosa di prezioso. In particolare, può fornirci importanti lezioni sui nostri limiti come esseri umani e come società. Da una prospettiva di decrescita, sulla quale sono posizionato da lunga data, mi sono sempre interrogato su quale approccio adottare per evitare la catastrofe ambientale che prima o poi, sperando sempre più nel “poi” che nel “prima”, colpirà l’umanità se non si adottano soluzioni drastiche per evitarla. Non intendo concentrarmi, in questo breve scritto, sulle politiche economiche o sull’ingegneria istituzionale, argomenti che sono stati già ampiamente trattati da altri. Voglio invece provare a riflettere sui principi fondamentali, anche se sono consapevole di non essere un filosofo, ma un economista di formazione con una passione per la storia e il pensiero antico.
La questione può essere posta in termini molto banali, ma significativi: l’uomo (inteso come genere umano) deve essere limitato? Questo è un argomento spesso discusso nei circoli di pensiero decrescente, anche se talvolta in modo implicito. Dietro l’idea di comunità, di dimensioni ridotte, di rinuncia consapevole e di vita frugale, c’è, a mio avviso, un unico elemento comune: la necessità per il genere umano di “limitarsi”. Tuttavia, l’idea di limite nel pensiero decrescente non rappresenta una proibizione, bensì una scelta consapevole che non solo ci aiuterà ad evitare la catastrofe, ma potrà anche renderci più felici, meno schiavi dei beni materiali superflui, di ciò che non serve se non ad affollare i nostri armadi, mentre invece dovremmo riempire e nutrire qualcosa di diverso, come la nostra anima. Per i decrescenti, tutto ciò ha un nome preciso, espresso in una frase coniata da Serge Latouche, il padre del pensiero decrescente: “decolonizzare l’immaginario”. Il nostro immaginario è costantemente bombardato dall’idea che il consumo sia indispensabile, poiché esso rappresenta il fulcro della nostra economia. Senza un aumento continuo della produzione e del consumo, il sistema rischia di collassare.
Questo ragionamento, seppur lodevole, coerente e necessario, porta tuttavia a conseguenze estreme, che possono essere riassunte in modo molto banale con la domanda: fino a che punto dobbiamo arrivare nella rinuncia consapevole? Questo è un problema fondamentale per un economista, poiché l’economista vede nell’innovazione il risultato dell’intraprendenza umana. L’innovazione, vista in modo ottimistico, comprende prodotti sanitari, vaccini, tecnologia medica e cibo abbondante per tutti. E l’intraprendenza umana, fondamento dell’innovazione, sempre in termini molto banali, si trova in una posizione diametralmente opposta ad una certa forma di rinuncia estrema, che possiamo chiamare antimodernismo integrale.
Arriviamo così alla domanda centrale: cosa implica l’antimodernismo nel contesto del pensiero decrescente, ma questa volta a un livello più ampio, ossia a livello macro? Nel contesto del pensiero decrescente a livello macro, l’antimodernismo rappresenta una critica radicale al paradigma moderno che promuove la crescita economica illimitata, l’espansione incontrollata e il consumo eccessivo. L’antimodernismo decrescente mette in discussione i fondamenti stessi della modernità, come il progresso tecnologico senza limiti, lo sviluppo economico costante e l’idea che la felicità umana sia intrinsecamente legata al possesso di beni materiali. A differenza delle buone pratiche a livello individuale, che si concentrano su azioni personali e comportamenti sostenibili, l’antimodernismo decrescente a livello macro propone una trasformazione radicale dei sistemi socio-economici e politici esistenti. Si basa sui principi di limitazione, sobrietà e il ritorno a una scala più umana. Da un lato, quindi, c’è la necessità urgente di limitarci, incluso il nostro approccio all’innovazione come conseguenza estrema. Dall’altro, se tutto diventa più “piccolo a livello di scala”, diventerà probabilmente impossibile sostenere certe attività a livello macro, anche quelle considerate universalmente virtuose. Inoltre, non è possibile decidere arbitrariamente quali attività meritino di continuare a esistere e quali no. La storia ci ha insegnato che ogni volta che qualcosa è stato imposto dall’alto, le cose sono sempre andate male. L’innovazione, così come la ricerca, devono essere libere da costrizioni e devono essere democratiche per produrre risultati apprezzabili. Questo è un dato di fatto che trovo importante sottolineare. Quindi come comportarsi non cercando di tirare fuori dal cilindro soluzioni istituzionali alternative o fantomatiche politiche economiche onniscienti e risolutive’
Finalmente si arriva a parlare del pensiero degli antichi, quello degli stoici in particolare. So che può sembrare una forzatura dopo tutto questo preambolo finire con il parlare di pensiero antico, ma forse mi permetto di dire, se lette in una maniera costruttiva, può davvero dare dei piccoli e utili suggerimenti. Gli stoici, con tutte le cautele del caso, hanno infatti una visione del mondo apparentemente fatalista e improntata all’accettazione della propria condizione. In una parola, il pensiero stoico greco-romano sembra essere la quinta essenza del limite.
Epitteto nel suo celebre manuale esordisce con: “le cose sono di due tipi, quelle che puoi controllare e ciò che non puoi controllare”. Le cose che non puoi controllare, per il filosofo, sono tutte quelle che non dipendono dalla tua volontà, come la salute, in una certa misura il successo e la ricchezza, le caratteristiche fisiche ecc. Ciò che invece puoi controllare sono principalmente le qualità dell’anima, il bene morale. Se si è in grado di accettare tutto ciò che non si può controllare e invece di indirizzare ciò che si può controllare, il proprio stato d’animo, si diventa immuni al destino e quindi invincibili, mortali ma invincibili. Questa accettazione, tuttavia, deve partire da un presupposto: tutto ciò che accade è giusto. Nel grande disegno dell’universo, tutto ciò che ci accade, per quanto individualmente triste e inaccettabile alla nostra ragione, ha uno scopo che noi non conosciamo né capiamo, ma che dobbiamo accettare. È inutile dire che l’idea del disegno divino cristiano ha preso ampiamente spunto da questa dottrina. La capacità di accettare e persino gioire, secondo gli stoici più integerrimi, è frutto del dono dell’uomo, della sua natura intrinseca, che è la ragione. La dottrina stoica è infatti in un certo senso estremamente giusnaturalistica: la felicità, nel senso degli antichi, cioè duratura e perfetta, dipende dalla capacità di ogni essere vivente di vivere secondo la propria natura universale e immutabile. In altre parole, seguendo le proprie inclinazioni. Marco Aurelio, Seneca e lo stesso Epitteto spesso fanno esempi di animali, come il lupo che per natura caccia, e il suo essere cacciatore lo rende adempiente alla sua natura e quindi felice. Lo stesso vale per l’uomo, che grazie al suo intelletto, elemento distintivo per gli stoici (e in generale per tutta la filosofia aristotelica e socratica), è in grado di comprendere il grande disegno divino e accettare in maniera stoica le difficoltà dell’esistenza in modo razionale. Accettando consapevolmente di essere una piccola parte dell’universo e del grande disegno. Quindi, secondo la filosofia stoica, la felicità risiede nella capacità di limitarsi a controllare ciò che è realmente nelle nostre possibilità. Dall’altra parte, gli stoici considerano l’intelletto umano come il cuore pulsante dell’essere umano. Pur non concependo l’intelletto in modo moderno, come una forza di innovazione e invenzione, gli stoici ne riconoscono l’importanza come caratteristica distintiva dell’uomo, che non dovrebbe essere quindi limitata ma bensì assecondata. Pertanto, in una prospettiva moderna, si può affermare che l’intelletto dovrebbe agevolarci nella comprensione dell’urgenza del problema climatico-ambientale e nel promuovere la cooperazione per il bene dell’umanità e la preservazione del nostro amato pianeta, proprio come suggerivano gli stoici?
Tuttavia, questo ci porta all’ennesimo paradosso di questo complesso pamphlet: come conciliare un certo antimodernismo con l’idea di intelletto come bene supremo, anche solo a livello di consapevolezza? Seneca, spesso criticato come un pensatore incoerente del suo tempo, sembra offrire una potente soluzione a questo paradosso. Egli suggerisce di non privarsi delle cose che si possono realizzare, ma di essere in grado di vivere senza di esse. Forse anche per giustificare la sua stessa posizione di privilegio e vita nel lusso, grazie alla sua vicinanza all’imperatore Nerone, Seneca afferma che è giusto possedere ricchezze se meritate, a condizione che si sia in grado di accettarne la perdita senza rimpianti. In queste parole, vedo ancora un chiarore confuso per il pensiero decrescente che cerca di unire la limitazione consapevole con il rischio di oscurare le immense e positive capacità umane. Questo può essere interpretato come un invito a non rinunciare alle capacità umane di innovazione e progresso, ma a sviluppare un atteggiamento di distacco e di accettazione nei confronti di ciò che potremmo perdere. In altre parole, si può apprezzare l’intelletto e le sue potenzialità senza esserne schiavi, riconoscendo la loro relativa importanza rispetto ai valori più profondi e duraturi.