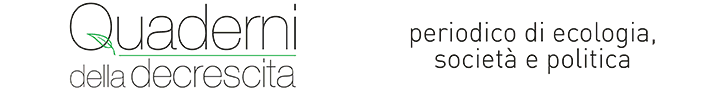Di Michela Mosoni
“Ho bisogno di una nuova borsetta, magari piccola, da usare la sera”.
“Mi serve un nuovo cellulare, con una fotocamera migliore”.
“Visto che inizierò ad andare a correre, devo acquistare qualche t-shirt e un paio di scarpe sportive”.
“Cosa faccio questo weekend?”.
Questi sono solo alcuni esempi dei pensieri che ci frullano per la testa ogni giorno.
Non ci soffermiamo sul significato, sull’opportunità, sugli stati d’animo che suscitano: sono lì, nella nostra mente e ci spingono a cercare cose, esperienze, novità, per placare un’inarrestabile sete, un’infinita serie di bisogni concatenati.
Eh sì, perché dopo la piccola pochette, servirà una borsa più grande e spaziosa, il cellulare necessiterà di una cover protettiva, le magliette andranno abbinate a dei pantaloncini e la domenica sera si comincerà a pensare a qualche nuova attività di svago per il fine settimana successivo.
Proviamo a chiederci il perché: perché sentiamo la necessità di acquistare?
Perché proviamo piacere nel comprarci qualcosa?
Perché, una volta soddisfatto un bisogno, subito un altro fa capolino dentro di noi?
Se si cerca di discernere fra l’essenziale e il superfluo, ci si potrebbe rendere conto dell’estraneità di quei bisogni che crediamo nostri.
Capita di desiderare qualcosa perché c’è chi, sui social network, in televisione, sulle riviste o nella nostra cerchia di amicizie, ritiene che sia necessario, punto.
Nel colmare quel vuoto proviamo soddisfazione, ma è una sensazione effimera, destinata a volatilizzarsi nel momento in cui ci accorgiamo che ci manca qualcos’altro, insomma, viviamo il nostro rapporto con i beni materiali come se stessimo cercando di riempire d’acqua uno scolapasta.
Ma perché soffermarsi a riflettere sui bisogni e sui consumi di ciascuno di noi?
Tutto ciò che ci circonda sembra indurci a consumare, va bene comprare oggetti, rinnovare l’arredamento o il guardaroba, uscire al ristorante, al cinema, al luna park, va bene perché “fa girare l’economia”.
Questo è il messaggio che ci raggiunge un po’ da ogni parte.
Il contesto economico in cui viviamo è improntato sulla crescita perpetua e trae da essa risorse per il proprio sostentamento: se si consuma, si pagano le tasse e si ottengono servizi, si lavora e si guadagna, in modo da poter continuare a consumare.
Funziona così.
Lo assumiamo come un dato di fatto, senza pensare che, in realtà, il sistema economico attuale non è un dogma, ma è stato preceduto, affiancato e potrebbe essere seguito da altri paradigmi, perché trattasi di un’invenzione dell’uomo.
Quello che tendiamo a ignorare, o che semplicemente mettiamo a tacere nel profondo della nostra coscienza, è che, dietro a ogni bene di consumo, c’è un processo produttivo, un impiego di risorse, trasporti che spesso coprono migliaia di chilometri, emissioni.
Senza contare i rifiuti, visto che all’interno di questo vortice consumista, gli oggetti tendono ad avere vita breve.
Consumare ha un costo ambientale che si sta rivelando sempre più insostenibile e distruttivo, eppure, paradossalmente, la nostra società non riesce ancora a distinguerne e ad ammetterne i connotati negativi.
Non si mette in dubbio l’atto del consumo, si pensa eventualmente di rivolgerlo a beni più eco-sostenibili (che, in verità, il più delle volte sono soltanto un po’ meno impattanti e talvolta nascondono risvolti di “green washing”).
Anzi, negli ultimi tempi si è assistito a un vero e proprio boom del “consumismo green”, in cui, paradossalmente, vengono scartati beni ancora in buono stato, per essere sostituiti da varianti più eco-compatibili.
Per comprendere questo meccanismo, è utile partire dal concetto di “immaginario”, definito dal filosofo, economista e psicanalista Cornelius Castoriadis come la “creazione incessante ed essenzialmente indeterminata (sociale-storica e psichica) di figure/forme/immagini”, costruita dalla società.
Secondo Castoriadis, la nostra società, nel corso degli ultimi quattro secoli, ha acquisito i paradigmi del sistema economico capitalista (basato sulla crescita) come necessità obiettive e universalmente condivisibili.
Tutti noi, fin dalla nascita, ne assumiamo i principi in maniera acritica, in quanto fattori ambientali inscindibili dal nostro contesto di vita.
L’economia ha così permeato il tessuto della nostra intera esistenza: riteniamo corretto e giustificabile tutto ciò che concorre alla sviluppo economico e alla crescita, anche qualora comporti un sovra-sfruttamento della biosfera, anche se inquini e deturpi, anche se comprometta la vita di organismi animali e vegetali.
Il nostro immaginario ci dice che consumare è bene: crea lavoro, ricchezza, benessere.
Anzi, è proprio il consumo lo strumento che ci rende parte della società, infatti, oggi, l’esclusione sociale non si basa più sull’estraneità al sistema produttivo o sul non riuscire ad accedere all’essenziale, ma sul non poter comprare per sentirsi parte della modernità.
Il povero, che fatica a omologarsi agli schemi comuni, si sente frustrato se non riesce a essere accettato nel ruolo di consumatore e vive una situazione di estromissione e rifiuto.
Ma è possibile ritrovare la propria libertà di pensiero e di autodeterminazione, attuando la “decolonizzazione dell’immaginario”, ossia operando una diseconomicizzazione della mente, prendendo coscienza che l’economia è un’invenzione sociale, culturale e storica su cui l’uomo può intervenire, modificandone le caratteristiche e dotandola di diversi significati, sollecitando un cambiamento di mentalità che permetta di approcciarsi ad altri valori, ulteriori modi di intendere il benessere e a un rinnovato atteggiamento verso la Terra e la società.
Il sistema attuale, per Castoriadis, sopravvive grazie al “culto del desiderio”, indotto attraverso l’aggressione pubblicitaria, che genera sovra-consumo e richiede continua produzione e crescita.
L’estrema varietà degli articoli offerti e la continua immissione di novità sul mercato, ci inducono a credere di vivere in una “società dell’abbondanza”, dove esiste di tutto e di più e ognuno può accaparrarsi ogni cosa e, grazie a questo, vivere meglio.
Ma in realtà, la nostra è una società dove impera la scarsità, non l’abbondanza, dal momento che si fonda sulla creazione continua di prodotti associati a nuovi bisogni, ma, all’aumentare di questi, si riducono le possibilità di soddisfarli.
Una società dell’abbondanza e del benessere (e anche più sostenibile), è quella che sa limitare i propri bisogni perché non è ossessionata dalla scarsità delle merci.
Si può però immaginare un altro mondo, un’altra civiltà dove sia possibile vivere bene, con poco e nel rispetto dei limiti ambientali.
Al centro dell’esistenza, è necessario però coltivare significati e valori diversi dall’espansione della produzione e dei consumi, consci del fatto che “benessere” non equivalga a “tanto avere”.
La soddisfazione e la felicità durature derivano infatti dai beni relazionali, privi di prezzatura e proprio per questo più rari e preziosi.
La via indicata è quella della decrescita, della condivisione, dell’autoproduzione, della cura dell’ambiente, dello scambio senza necessariamente contropartita monetaria, della rivalutazione del “valore d’uso” a discapito del valore commerciale, della riscoperta delle emozioni e delle attitudini personali nel rapporto con il resto del mondo.
Questi traguardi possono essere raggiunti attraverso un percorso interiore accompagnato da azioni di condivisione, denuncia ed educazione rivolte all’esterno, che possono riformare il sistema e donare speranza all’umanità e al pianeta.
Bibliografia:
“La scommessa della Decrescita”, 2006, Serge Latouche
“L’economia dell’età della pietra”, 1980, Marshall Sahlins
“L’istituzione immaginaria della società”, 1975, Cornelius Castoriadis
“Modernità liquida”, 1999, Zygmund Bauman
“Bioeconomia”, 2003, Georgescu-Roegen