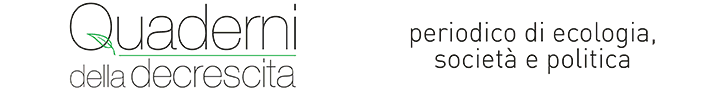Pochi, anche a sinistra, comprendono qual’è la posta in gioco e quanta libertà sia consentita da una crisi come quella attuale.
“Ma tu lo sai quante crisi ha attraversato il capitalismo? E quali speranze ogni volta sono nate nel mondo del lavoro?Speranze poi puntualmente crollate di fronte a clamorosi rilanci del sistema, alla conquista di nuovi pezzi di mondo?”
Di questo tenore è di regola la risposta delle sinistre quando si avanzi l’idea che, forse, la crisi attuale potrebbe proporsi come occasione per provare a ripensare il mondo, magari guardando il capitalismo come un fenomeno non necessariamente eterno. Le eccezioni non mancano, ma sono rare, e di solito non vanno oltre l’auspicio.
D’altronde lo stanco scetticismo delle sinistre circa un possibile superamento del capitalismo non può stupire. Nulla di simile gli ultimi secoli della nostra storia promettono o autorizzano a sperare. Ma si dimentica che la storia è fatta di cose che prima non c’erano. E la storia più recente è stata appunto un lungo succedersi di fenomeni nuovi, non pochi di dimensioni clamorose, che contribuiscono a fare di quella attuale una crisi decisamente diversa.
Oggi, parlando di crisi, ci si riferisce a quella che ha colpito prima le grandi banche americane, poi la finanza mondiale, e ora va mettendo in panne l’economia tutta intera, con pesanti ricadute su occupazione, condizioni dei ceti più deboli, ecc. Ma in realtà le crisi che scuotono il mondo oggi sono due, la seconda non meno della prima determinante per il nostro futuro; due crisi (a parere di non pochi cervelli di tutto rispetto) strettamente connesse l’una all’altra. Mi riferisco alla crisi ecologica planetaria, che la politica – di sinistra come di destra – ha a lungo ignorato, nonostante i sempre più allarmati richiami della scienza mondiale; che solo di recente ha preso in considerazione, ma solo per alcuni aspetti, e con provvedimenti lontanissimi dall’essere risolutivi. Inoltre senza mai considerarne il diretto rapporto con il sistema produttivo.
Eppure il problema è tutt’altro che sconosciuto. Fin dal primo affermarsi del capitalismo industriale grandi pensatori della scienza economica e non solo sono andati interrogandosi sull’aporia di una produzione in crescita esponenziale all’interno di uno spazio dato e non dilatabile quale il pianeta Terra, costretta pertanto a confrontarsi con l’inevitabile esauribilità delle risorse di cui si alimenta. La cosa apparve poi inoppugnabile quando (particolarmente per merito di Nicholas Georgescu Roegen,(1) che in base al 2° principio della termodinamica dimostrò l’inevitabile e irreversibile degrado dell’energia e delle materie prime impiegate nei processi produttivi industriali) fu scientificamente provato che il capitalismo andava consumando la base stessa del suo operare. E sempre più risultò evidente via via che (stagioni impazzite, ghiacci polari disciolti, alluvioni cicloni tornado sempre più devastanti, enormi ingestibili mucchi di rifiuti, 3 milioni di morti, 50 milioni di profughi) il guasto degli ecosistemi è andato palesandosi in tutta la sua terribilità.
Pagine e pagine di tutti i giornali sono dedicate a questi temi; puntualmente si rende noto che, secondo la scienza più accreditata, le risorse disponibili sono in via di esaurimento, e che continuando a consumare al ritmo attuale presto avremmo bisogno di 5,4 pianeti; che buona parte delle coste del globo finiranno sott’acqua, quelle italiane per prime; che in molte città respirare è un grave rischio. Eccetera. Ma sono i medesimi organi d’informazione a dedicare spazi ancor più ampi e vistosi alla preoccupazione per l’auto che non “tira” come dovrebbe, al Pil che non cresce abbastanza, ai mercati che rischiano una battuta d’arresto: facendosi tramiti convinti, e spesso entusiasti, dell’invito al consumo. La crescita – non importa se all’interno di uno spazio che non può crescere – rimane la nostra stella polare.
Una sorta di schizofrenia che appartiene d’altronde all’intero agire economico e sociale. Basti ascoltare qualche convegno tra grandi industriali, magari affiancati da illustri economisti e noti politici: da sempre, e ancora oggi, l’ambiente, i rischi che anche all’economia il suo dissesto comporta, sono del tutto ignorati, o evocati per brevi accenni. Ma lo stesso accade se l’ascolto è dedicato a un dibattito tra sindacalisti, politici di sinistra, economisti di analoga collocazione politica. Come se non fosse la natura, l’ecosistema, a fornire tutto quanto il lavoro trasforma, quanto consente all’impresa di esistere, all’economia di operare. Come se non provenisse dalla natura, non “fosse natura”, tutto quanto vediamo, tocchiamo, usiamo, indossiamo, mangiamo, beviamo, respiriamo… Per tutti, imprenditori, banchieri, economisti, politici di ogni colore, il collasso degli ecosistemi non è che una variabile marginale, di cui è inevitabile occuparsi quando causa danni di qualche entità: una seccatura insomma, un disturbo collaterale, nulla che riguardi le radici dell’agire economico.
Accennavo sopra ad alcuni aspetti del problema ambiente che economisti e politici da alcuni anni hanno preso in seria considerazione; i quali però con le cause della crisi ecologica non hanno molto a che fare, non almeno nei modi e per i motivi dell’interessamento. E’ dall’inizio del 2000 che la “fine del petrolio”, o comunque la crescente antieconomicità della sua estrazione, suscita viva preoccupazione tra economisti e politici; e anche l’innalzamento della temperatura del globo comincia a suscitare qualche interrogativo negli ambienti che “contano”. Nasce così un interesse via via più vivace per le energie alternative (vecchio cavallo di battaglia dei Verdi, a lungo duramente osteggiato dalle compagnie petrolifere) e per ogni ritrovato capace di assicurare risparmio energetico; ciò che presto dà luogo a un fiorente “green business”. E la parola stessa dice quale sia il vero, o comunque prioritario, scopo di questa nuova politica, di fatto opposto a quello per cui si batte l’ambientalismo più qualificato, e per cui le stesse “rinnovabili” sono state pensate.
Di questo genere sono oggi, in presenza della recessione mondiale, i soli provvedimenti dedicati all’ambiente da tutti i governi. D’altronde in perfetta sintonia con le posizioni che ignorano lo squilibrio ecologico in tutta la sua complessità, limitandolo all’”effetto serra” (certo la sua manifestazione più vistosa e devastante, ma non la sola, né risolvibile con i mezzi proposti) così da diffondere l’illusione di un possibile felice futuro, che grazie al “green business” garantirà un forte rilancio della crescita, consentendo produzione e uso di motori di ogni sorta, senza limiti e al netto da inquinamenti. In linea dunque con l’insistita sollecitazione al consumo rivolta a popolazioni impoverite, indebitate, disoccupate; con l’imperterrita strategia della cementificazione, che va programmando grattacieli, superstrade, alte velocità, nuovi piccoli e grandi aeroporti, villaggi e porti turistici, interi quartieri destinati a restare, come in Usa, invenduti; e con la logica che affida al mercato e alle sue “leggi” il compito di dettare la politica economica, solo nell’eccezionalità del momento disponibile a una momentanea deroga che affidi allo Stato la salvezza di giganti finanziari e industriali in bancarotta.
E però sono sempre più numerose le voci – anche di commentatori lontani da ogni estremismo – che apertamente denunciano l’insensatezza di questa linea e in vario modo argomentano la necessità di superare, o comunque ripensare, il capitalismo. L’elenco è lungo e include grandi nomi della cultura mondiale: Eric J.Hobsbowm, Edgard Morin, Jurgen Habermas, Ulrich Beck, Nicholas Stern, Paul Virilio… E, nell’ambito di questa lettura nettamente critica dell’economia mondiale, è di particolare interesse l’affermazione e la messa a fuoco di una radice comune delle due crisi, quella economico-finanziaria e quella ecologica, da alcuni intuita più che dimostrata, ma dettagliatamente analizzata da altri.
Il primo non solo a intuire ma a descrivere il modo in cui i due fenomeni si influenzano a vicenda, è stato André Gorz, il quale, in particolare in un articolo pubblicato poco prima della sua morte(2), con parole addirittura profetiche ha indicato nella sovrapproduzione l’origine della crisi finanziaria. Egli nota infatti come l’enorme massa monetaria, derivante dalla vendita delle merci prodotte in quantità sempre più massicce, e in crescente difficoltà nella propria messa a profitto, sempre più si orienti a investire nell’”industria finanziaria”: quella che “crea danaro mediante danaro (…) comprando e vendendo titoli finanziari e gonfiando bolle speculative”, dando l’impressione di grande floridezza economica, ma fondata “in realtà su una crescita vertiginosa di debiti di ogni sorta (…) destinata prima o poi a esplodere, portando al limite al crollo del sistema bancario mondiale”.
La sovrapproduzione è d’altronde un fenomeno che Gorz in precedenza aveva ampiamente studiato come tipico dell’economia capitalistica, connesso alla stessa meccanica dell’accumulazione e promosso dalla cultura consumistica(3). E appunto l’assurdo del consumismo, cioè della “quantità in continua espansione” (dimensione precipua del capitalismo, fisicamente incompatibile con le dimensioni della Terra) aveva segnalato come causa principale dello squilibrio ecosistemico. In questa analisi trovando accenti vicini al pensiero di Immanuel Wallerstein(4) che, pur senza specificamente occuparsi di ambiente, si è ripetutamente soffermato sulla progressiva riduzione di spazi disponibili all’espansionismo del capitale; anche lui dunque indicando nei “limiti del pianeta” una delle cause della crisi “sistemica”, che da anni diagnosticava come irreversibile.
Ad accomunare le due crisi, e a ricondurle a un’unica origine, cioè l’insostenibilità (fisica oltre che sociale) del capitalismo, è anche il celebre antropologo Jared Diamond(5). Di “due minacce”, entrambe determinate dai processi di globalizzazione parla in un suo ponderoso saggio l’economista indiano Prem Shankar Jha(6). Sul complesso effetto negativo – sociale, ambientale, finanziario – della globalizzazione neoliberista, insiste anche Walden Bello(7). “Le due crisi si alimentano a vicenda”, scrive il prestigioso notista politico George Monbiot(8)… L’elenco è assai più lungo di così. D’altronde non manca soltanto un elenco completo degli autori, bensì un quadro organico di questo ormai nutrito filone di pensiero. Il perché non è difficile da intuire: si tratta di posizioni che parlano dell’impossibilità di trovare soluzione ai tremendi problemi attuali all’interno del capitalismo, ed esprimono ben scarsa fiducia in una sua piena ripresa; posizioni opposte a quelle prevalenti, coltivate dai media e dalle più potenti agenzie d’opinione. Che si tenda a ignorarle non può stupire: come sempre “le idee dominanti sono quelle delle classi dominanti”.
E qua ci si ritrova al punto da cui questo articolo si è mosso. Al fatto cioè che tra le sinistre manchino tentativi di leggere il terremoto che scuote oggi la società come un’occasione per ripensarla: provarci almeno, sperarlo, sognarlo… Ripeto: rilancio produttivo, crescita, consumi, sono le parole d’ordine anche a sinistra, e anche tra i pochi che indicano il capitale come “il nemico” da combattere. E non serve dire che tra le organizzazioni del lavoro questi obiettivi hanno fini e urgenze diversi da quelli delle destre; o che è più facile trovare occupazione in un’azienda in ripresa piuttosto che in una in pieno dissesto. Sono indubbie verità ma di breve respiro, certo da considerare nella pratica immediata, ma che non dovrebbero inibire il coraggio di guardare più lontano, di capire che oggi nemmeno le cose di casa nostra si possono risolvere, o anche solo leggere correttamente, se non si guarda al mondo, del quale le cose di casa nostra sono ormai parte più o meno omogenea; e che a guardarlo attentamente, il mondo, si capisce che così com’è non regge più. Come concordemente ritengono i commentatori appena citati. I quali tra l’altro, tutti, fanno riferimento all’ambiente quale determinante della nostra condizione presente e futura.
Problema che le sinistre, alla pari delle destre, hanno a lungo rifiutato di considerare, e che neppure oggi seriamente considerano, quanto meno non nella sua complessità: accodandosi all’entusiasmo per le “rinnovabili” e in generale per il “business verde”, sempre in funzione dell’auspicato “rilancio produttivo” (ripeto, non proprio la medicina più adatta alla malattia), e magari genericamente riferendosi alla “qualificazione” dell’ambiente, mentre (fatta eccezione per alcune “sinistre critiche”) ignorano, o apertamente contrastano, le battaglie locali (Tav, Dal Molin, Civitavecchia, ponte di Messina, ecc., per limitarmi ad alcuni casi italiani) che, benché limitati, sono coerenti antefatti di quella che dovrebbe essere la giusta cura per la natura gravemente ammalata.
Anche Claudio Napoleoni si interrogava su questa “timidezza” delle Sinistre, quasi una “sorta di complesso di inferiorità nei confronti di quelle che vengono chiamate le leggi economiche”; per cui – diceva – “nei partiti comunisti c’è sempre stato un curioso miscuglio, di esigenza di superamento del capitalismo e di paura di disturbare un assetto al di fuori del quale non sembra esistere possibilità di ordine.”(9) E forse sarebbe utile chiedersene il perché, magari rileggendo la storia, non per concedersi ai rimpianti o impegnarsi al recupero di identità perdute, ma per capire come è nata quella quota di “industrialismo” che innegabilmente appartiene alle sinistre. Che forse addirittura risale al momento in cui Henry Ford spontaneamente aumenta il salario dei suoi operai perché comprino le sue auto: cioè al primo gesto esplicito compiuto dalla grande industria al fine di reperire un bacino di consumo adeguato alla programmata dilatazione dei mercati; avvio di quel processo di assimilazione della classe lavoratrice a valori e modelli funzionali alla crescita del prodotto, impostasi poi come una sorta di mutazione antropologica. Mentre la “rivoluzione”, pur senza mai essere cancellata come obiettivo ultimo delle sinistre, in qualche modo “entrava in sonno”.
La cosa d’altronde ha certo comportato anche risultati positivi. Per decenni in Occidente le sinistre hanno avuto spazio per conseguire cospicui miglioramenti nelle condizioni dei lavoratori; in qualche modo creando anche una larga speranza di ricchezza per tutti. Speranza poi duramente delusa con la netta inversione di tendenza degli ultimi decenni: sia nella sempre più disuguale distribuzione del reddito (oggi l’1 % della popolazione del mondo ne detiene il 50%), sia nella crescente insicurezza (di occupazione, di mansione, di salario, di orario) che caratterizza il lavoro e il suo abuso; una precarietà diffusa, cui anche la percezione del rischio ambientale si somma in un pesante disagio. Il tentativo di salvarci da questa realtà, e dal terrificante futuro che potrebbe seguirne, esige un deciso scatto di fantasia, oltre che un’enorme dose di coraggio: recuperando l’idea di “rivoluzione”, ma ripensandone il senso e i modi alla luce dell’ultima storia.
“Violento, profondo rivolgimento dell’ordine politico-sociale costituito, tendente a mutare radicalmente governi, istituzioni, rapporti economico-sociali”, così (non troppo diversamente da analoghi repertori) recita “Il Nuovo Zingarelli” alla voce “Rivoluzione”(10): descrivendo (a mio parere con buona approssimazione) ciò che un’azione capace di conseguire un soddisfacente risanamento degli ecosistemi, così da garantire il futuro della specie umana, richiederebbe. Vale a dire (come quasi vent’anni fa André Gorz già lucidamente intendeva) l’assunzione dell’ equilibrio ecologico come asse portante di un nuovo ordine mondiale: per una trasformazione del paradigma economico, con “un rallentamento dell’ accumulazione”, e dunque un calo generale dei consumi e della distruzione di risorse, ma insieme con un nuovo impianto dei rapporti sociali non più “motivato dall’opportunità economica”, e definito invece soprattutto da una decisa correzione delle disuguaglianze.(11) Superamento del capitalismo dunque, e generale ripensamento della convivenza umana e degli istituti che la definiscono e governano. La rivoluzione, appunto. Rivoluzione ecologica, economica, sociale, culturale.
Una rivoluzione che somiglia pochissimo a quelle del passato. L’aggettivo “violento”, che apre la “voce” dello Zingarelli sopra riportata, fa riferimento a quello che è stato finora il tratto precipuo di tutte le rivoluzioni, nei loro processi come nel loro assunto. Ma questo è ciò che occorre superare, per inventare una rivoluzione diversa. In altra occasione(12) ho parlato di una “rivoluzione dolce”, incisiva e tenace e però priva di eventi traumatici e sanguinosi, che in nessun modo preveda uso della forza. Forse, chissà, l’obiettivo di questa nuova rivoluzione, e i suoi processi, potrebbero magari imporsi come incontestabili, addirittura ovvie, necessità. E’ lo stesso Gorz a suggerirlo: “Alla lunga, ciò che è ecologicamente irragionevole, non potrà essere economicamente razionale”.(13)
Certo, è comprensibile come un’impresa di tale portata, anche quando si ritenga non infondata nelle sue ragioni, difficilmente possa trovare concreta disponibilità. Da che parte incominciare, è un interrogativo che pare senza risposte. A meno che non sia la crisi stessa a dare suggerimenti. Di recente più d’uno ha avanzato l’idea di una forte riduzione degli orari di lavoro così da poter “dividere equamente” la disoccupazione, e/o sostituire la cassa integrazione. La proposta ha incontrato un certo ascolto, qualcuno si è spinto a recuperare l’ipotesi sessantottina del “salario di cittadinanza”, ne è nato un minimo di dibattito. Insomma dalla mancanza di lavoro, che per molti è già una dura realtà e per moltissimi una disperante prospettiva, si è rimesso in pista un discorso cui qualche decennio fa si era guardato come alla possibilità di una vera, grande rivoluzione, individuale e sociale. Dopotutto, dove sta scritto (se non appunto nelle logiche del capitalismo industriale) che la più gran parte della vita debba essere spesa lavorando? Ma la “rivoluzione del tempo” è una possibilità da potersi recuperare (anche) al fine di quel rallentamento dell’accumulazione capitalistica necessario a una concreta difesa dell’ambiente, oltre che presupposto di rapporti sociali più equi.
Alla proposta non poteva non seguire la domanda “Chi paga?”. Ma subito si è risposto ricordando che Luigi Einaudi, che non era un barricadero, teorizzava l’esigenza di un’imposta patrimoniale di successione che, oltre una certa soglia di reddito, tassasse i patrimoni per un’aliquota del 50 %, al fine di combattere le disuguaglianze. Nato senz’altro obiettivo che la difesa dell’occupazione, senza mettere in discussione il rilancio produttivo, il discorso relativo ai tempi di lavoro (uno dei temi più carichi di implicazioni politiche, sociali e esistenziali, caro a tutti i grandi utopisti, e su cui anche Marx ha a lungo ragionato) potrebbe dunque trovare futuro proprio entro la prospettiva di “rivoluzione” di nuovo conio cui accennavo. Come si vede, se si trova il coraggio di uscire dai vicoli asfittici della piccola politica consueta, si trovano anche le ragioni per sostenerlo e pure gli antefatti su cui appoggiarlo.
Ma c’è un altro tema, presente nel frantumato dibattito di quel che resta delle sinistre, che potrebbe partecipare alla medesima ipotesi, divenirne forse materia decisiva. Penso al pacifismo, alla sua denuncia della guerra praticata come normale strumento politico, che un’idea di rivoluzione non violenta non potrebbe ignorare. Anche perché la guerra, tra l’altro, è agente crudelissimo di devastazione ambientale. A partire dalle armi: merci che pesantemente inquinano, nell’essere prodotte, trasportate e “consumate”; merci che rappresentano oggi il 3,5% del Pil mondiale (cifre ufficiali, assai inferiori alla realtà, dato il floridissimo contrabbando del settore) e che costituiscono uno dei pochi mercati oggi in crescita; al rilancio del quale, secondo autorevoli opinionisti, non è estraneo il moltiplicarsi di guerre, guerriglie, terrorismi. Qualora, per (oggi pressoché surreale) ipotesi, la produzione di armi venisse proibita, questa da sola costituirebbe una concreta risposta alla necessità ecologica di contenere la produzione; oltre a inserirsi nel modo più naturale in quella “rivoluzione diversa”, ecologica economica sociale culturale, di cui dicevo.(14)
Insomma, se le sinistre ci provassero a considerare la possibilità di un mondo senza capitalismo, forse oggi l’impresa non sarebbe del tutto disperata.
Tratto da: Alternative per il Socialismo, n.8, gennaio-febbraio 2009.
NOTE
1) Cfr. Nicholas Georgescu-Roegen, “The Entropy Law and the Economic Process”; Cambridge (Mass) 1971
2) A. Gorz, “Crise mondiale, décroissence et sortie du capitalisme”, in « Entropia », Printemps 2007, pp. 51-59.
3) A. Gorz, “Capitalismo, socialismo, ecologia”, Roma 1992.
4) CfrI. I. Wallerstein, “Dopo il liberalismo”, Milano 1999, e “Il declino dell’America”, Milano 2004.
5) Cfr. J. Diamond, “Collasso”, Torino 2005.
6) Cfr.P. Shankar Jah, „Il caos prossimo venturo“, Vicenza 2007.
7) Walden Bello, “Deglobalizziamo”, intervista a cura di G. Battiston, Il manifesto 11-12-08.
8) George Monbiot, The Guardian 12–12-08.
9) Claudio Napoleoni, in “La politica degli orari di lavoro”, Dialogo in appendice a Carla Ravaioli, “Tempo da vendere, Tempo da usare”, 2° edizione. Milano 1988. p. 144.
10) Zingarelli, “Vocabolario della lingua italiana”, Bologna 1990, p. 1651.
11) A. Gorz , “Capitalismo, Socialismo, Ecologia”, cit. pp. 72-78 passim.
12) C. Ravaioli, “La crescita non è illimitata”, “Carta” giugno 2004.
13) A. Gorz, “Capitalismo, Socialismo, Ecologia”, cit. p. 74.
14) Cfr. Carla Ravaioli, “Ambiente e pace – Una sola rivoluzione”, Milano 2008.