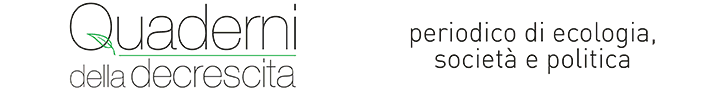recensione di PAOLO CACCIARI

Credo che questo libro abbia la forza argomentativa e la chiarezza espositiva necessarie per far uscire la proposta della decrescita dal cono d’ombra dentro cui l’ha relegata il pensiero economico mainstream. Jason Hickel è un giovane antropologo inglese che – per sua stessa ammissione – è “venuto a conoscenza tardi di tutte queste cose” che descrive nel libro e ne è “rimasto colpito” (p.167).
Per chi, come me, cerca di osservare e studiare “queste cose” da oltre mezzo secolo (il prossimo anno sarà il cinquantenario della pubblicazione dei Limiti della crescita del Club di Roma), le fresche riflessioni di Hickel arrivano come una ventata di speranza. Forse, non è più un tabù mettere in discussione, non solo gli eccessi del capitalismo (la finanziarizzazione, la globalizzazione neoliberista, le rendite smodate, il gigantismo delle corporations, le odiose e crescenti iniquità, gli sprechi, la corruzione e la disonestà), ma la sua stessa essenza: la crescita economica misurata in valore di scambio delle merci collocate sul mercato. Vale a dire quel meccanismo esponenziale diabolico che obbliga il sistema a realizzare profitti da accumulare per investire per produrre sempre più profitti da reinvestire in un moto perpetuo elicoidale accelerato (D→M→D’→M’→D’’→…) che cattura, estrae e divora le “risorse” umane e naturali.
“Un ciclo che si autoalimenta, un tapis roulant in continua accelerazione: il denaro diventa profitto che diventa più denaro che diventa più profitto” (p.87). Annota Hickel. “La crescita è un imperativo strutturale, una legge ferrea” del capitalismo, (p.33), poiché il suo fine non è l’utilità del prodotto che l’impresa capitalista mette sul mercato ma il profitto che la sua vendita permette di realizzare. Da qui la necessità di creare continuamente nuovi mercati, nuovi oggetti, nuovi bisogni. “Se non si cresce si crolla” (p.215).
Il titolo originale del libro è netto: Less Is More: How Degrowth Will Save The World. Non si sa perché l’editore italiano abbia deciso di distorcerlo ed edulcorarlo, censurando la parolina urticante “decrescita” e riducendo la questione della salvezza del pianeta ad una faccenda economica.
La tesi dell’autore, invece, è tanto complessa quanto radicale. La decrescita è un’idea di cui non si può fare a meno – scrive – perché ci fa uscire dal “culto della crescita” e “ci scuote dallo stordimento” (p.261) di una ideologia totalizzante, di una “metafora potente”, per di più, apparentemente democratica, poiché allude alla possibilità di un miglioramento infinito, per imitazione e “gocciolamento”, del tenore di vita di ciascun individuo. Inoltre Hickel ci avverte: “Concentrando tutta la nostra attenzione (solo) sul modo in cui aggiustare l’economia, rischiamo di non vedere il quadro completo.
Sì, dobbiamo compiere passi per andare oltre il capitalismo. Ma il capitalismo è soltanto il fattore trainante immediato della crisi che fronteggiamo: non è veramente la causa di fondo. Questa va ricercata a un livello molto più profondo” (p. 229). Che afferisce alla sfera culturale, all’universo mentale, all’antropologia, all’etica, alla spiritualità. Vale a dire il modo in cui le persone vedono e vivono la realtà, percepiscono sé stesse nel mondo, approntano le relazioni con l’altro da sé e con la natura, concepiscono l’“ontologia dell’inter-essere” (p.67). “Non è soltanto la nostra economia a dover cambiare. Dobbiamo cambiare la nostra visione del mondo e il nostro posto nel mondo” (p.43), scrive Hickel.
Se fosse solo una questione “economica” la battaglia del cambiamento verso un sistema meno irrazionale, controproducente e “antieconomico”, forse, sarebbe stata vinta da un pezzo, considerando l’enormità dei suoi costi umani e ambientali. L’insostenibilità ambientale e l’insopportabilità umana del “capitalocene” è ormai evidente a tutti. Climat change, Sesta estinzione di massa, plastificazione degli oceani, desertificazione dei suoli… ed ora, pandemie da spillover, sono catastrofi entrate nelle agende politiche, ma nessuno – non solo ai piani alti delle gerarchie sociali – ha il coraggio di trarre le conseguenza ultime: entrare nell’ordine di idee che sia necessario uscire dall’economia della crescita.
Evidentemente, per dare una spiegazione alla “dissonanza cognitiva” (concetto usato anche da Naomi Klein) e alla perdita di senso dell’agire umano, c’è bisogno di ritornare alla vexata question su cui già si interrogava Étiénne de La Boétie agli albori del capitalismo e che definiva “servitù volontaria”; la più potente arma dell’“arte del regnare” con il consenso dei dominati. Hickel, rifacendosi a Gramsci, pensa che vi sia un problema di “egemonia culturale” che impedisce al 99% della popolazione umana di liberarsi dal dominio dell’1% più egoista e prepotente. Ma, allo stesso modo, scommette sulla capacità di ogni individuo di immaginare un mondo diverso, postcapitalista.
Per rovesciare la configurazione delle strutture sociali di potere – così asimmetriche, arroganti e violente – occorre quindi demolire l’idea di fondo che legittima i potenti a sottomettere i più deboli e a colonizzare il mondo. Questa cattiva idea è “il principio di dominio”, responsabile in ultima istanza della crisi ecologica, che secondo Hickel diventa egemone con la concezione filosofica dualistica del mondo (Francis Bacon e René Descartes, sul versante scientifico, Thomas Hobbes e John Locke, su quello socio-politico), secondo cui gli esseri umani sono soggetti superiori, gli unici dotati di spirito e intelletto, separati dalla natura e autorizzati a trattarla come oggetto inerte e meccanico, come “risorsa”.
La natura, da madre amorevole e nutrice, secondo tutte le culture animiste precedenti, diventa “comune prostituta” (Bacon), una “bestia” che va “forzata e mantenuta in ordine” attraverso la scienza e le tecnologie. La recinzione dei beni comuni (enclousures dei commons) all’interno dell’Europa e la colonizzazione delle terre selvagge all’esterno, sono le cifre che segnano la “missione civilizzatrice” degli imperi europei. Ci pensarono poi l’Illuminismo, la rivoluzione industriale e l’urbanizzazione a portare fino alle ultime conseguenze la visione antropocentrica del mondo. I cicli vitali diventano “servizi ecosistemici”, i patrimoni territoriali diventano “stock di capitale naturale” e “materie prime”. “Fin dagli inizi, il capitalismo è in guerra contro la vita stessa.” (p.81) – afferma Hickel. “Non c’è più nulla di naturale o di innato nei comportamenti produttivistici che associamo all’homo oeconomicus. Questa creatura è il prodotto di cinque secoli di riprogrammazione culturale” (p.77). “Storicamente la crescita è sempre stata un processo di appropriazione di energia e di lavoro forniti da natura e (alcune categorie) esseri umani” (p.83).
In questa breve nota ho seguito il consiglio dato dall’autore al lettore già aggiornato sull’andamento del biocidio in atto, descritto con precisione nella prima parte del libro, e non mi sono soffermato su dati e processi in gran parte già noti e scientificamente provati .
“Viviamo in un mondo agonizzante” (p.29). Abbiamo sfondato i “confini planetari” (Johan Rockström), i limiti della rigenerazione della biocapacità del pianeta. “Stiamo assistendo al cedimento di numerosi ecosistemi interconnessi, sistemi cruciali per la sopravvivenza del genere umano” (p.18). Basti pensare che “il tasso di estinzione (delle specie viventi) oggi è mille volte superiore a quello stimato prima della Rivoluzione industriale” (p.21).
Ciò che gli studi comparati tra ecologia ed economia di Hickel aggiungono è il comprovato fallimento delle due grandi promesse degli ultimi decenni: lo “sviluppo sostenibile” e l’“economia circolare”. Vale a dire il cosiddetto disaccoppiamento (decoupling) tra crescita del Pil e crescita dei flussi di materia e di energia impiegati nei cicli produttivi, da una parte, e, dall’altra, il loro riutilizzo, magari attraverso pericolosissime tecniche fantascientifiche di geoingegneria come quelle per la cattura, il confinamento e il riutilizzo della CO2. “Man mano che il Pil cresce, l’economia globale consuma ogni anno più energia e più risorse e produce più scarti” (p.31).
Alla faccia della smaterializzazione dell’economia, l’impronta materiale globale va di pari passo del Pil mondiale. In un contesto di tipo capitalista non c’è alcuna “speranza che la tecnologia ci salverà”. La “crescita verde non esiste” (p.34), è un ossimoro. Interessante notare che a queste stesse conclusioni cominciano a giungere anche ricerche importati ufficiali.
L’ultimo rapporto dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), Crescita senza crescita economica, pubblicato da poco, conferma la fallacia dell’ipotesi di un disaccoppiamento assoluto e di una circolarità al 100%. Insomma la decrescita, nel suo primo, elementare significato di “riduzione pianificata dell’utilizzo di energia e di risorse per ristabilire l’equilibrio tra economia e il modo vivente in maniera sicura, giusta ed equa” (p.39), è più che mai necessaria e urgente.
Ma attenzione, nessun pauperismo, nessuna rinuncia, nessuna austerità. Lo scopo del libro, scrive l’autore, è “far capire che possiamo ottenere importanti riduzioni di volume di produzione materiale senza alcun impatto negativo sul benessere umano” (p.201).
Infatti, non è difficile immaginare le regole di una economia postcapitalista. Se le qualità dei beni e dei servizi fossero migliori (durevolezza, riparabilità, sostituibilità) così come la loro accessibilità e condivisione, vi sarebbe meno necessità di produrli, meno tempo di lavoro da dedicarvi, meno materiali da prelevare, meno energia da impiegare. Se la moneta creata dal debito bancario venisse regolata e gli interessi composti sui debiti fossero limitati a quelli “semplici”, non vi sarebbe bisogno di indebitarsi per pagare i debiti che poi corrono nelle tasche degli “investitori” (ovvero delle “persone in possesso di capitale accumulato.” p.88). Inoltre si potrebbe ipotizzare l’introduzione di “un sistema di tetti, tasse e dividendi” (p.202 ) comprendente un salario minimo globale e un tetto annuo al prelievo di risorse.
Infine basterebbe cambiare i manometri sulla plancia di comando introducendo più raffinati indicatori di progresso, benessere e sviluppo umano, diversi dal rozzo Pil.
Insomma, non è l’economia lo scoglio più difficile da superare, ma sradicare dalle menti l’idea che per esaudire i nostri bisogni e i nostri desideri sia necessario produrre merci in quantità sempre maggiore e più in fretta. La transizione ecologica riguarda prima di tutto l’atteggiamento mentale.
Se riusciremo a superare l’idea di una natura avara e scarsa e a vederci invece come sua parte, allora, forse, la considereremo non solo sufficiente e bastevole, ma abbondante. Sono questi “gli insegnamenti degli antenati” (p.230) cewong, achuar, bedamuni, kanak… che in veste di antropologo Jason Hickel ricorda nel suo libro. A me è venuto in mente anche il capo indiano Seattle che nel 1854 diceva: “Noi siamo parte della Terra ed essa fa parte di noi”.
4 maggio 2021
Titolo originale: Less Is More: How Degrowth Will Save The World.
Siamo ancora in tempo! Come una nuova economia può salvare il pianeta
Il Saggiatore 2020, pp. 287, Euro 23.