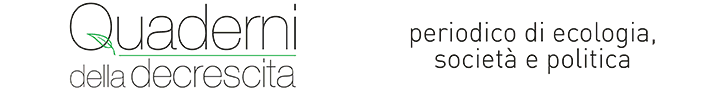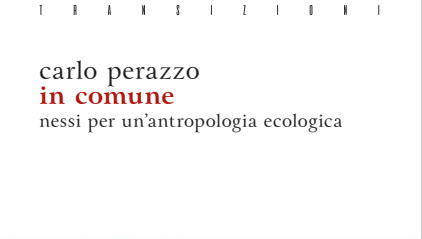
“In comune. Nessi per un’antropologia ecologica” è il nuovo libro di Carlo Perazzo, edito nella collana “Transizioni” di Castelvecchi.
“Transizioni“ è una collana diretta da Mauro Bonaiuti, Marco Deriu e Serge Latouche, dedicata ai temi della decrescita, della giustizia ambientale, del dopo-sviluppo e dell’ecologia politica, ovvero alla presentazione di prospettive ed esperienze di trasformazione radicale del presente e di prefigurazione di una società ecologica e conviviale. L’obiettivo è di esporre in maniera organica temi e proposte che raccontino realtà socio-culturali e movimenti politici attivi e propositivi capaci di ispirare ulteriori esperienze valorizzando le contaminazioni, le intersezioni, le convergenze.
Qui di seguito pubblichiamo, per gentile concessione degli autori e della casa editrice, la prefazione di Stefania Consigliere e un estratto del libro di Carlo Perazzo.
Prefazione – di Stefania Consigliere
Se il capitalismo è ancora e sempre un’immane violenza che spazza via ogni organizzazione “altra” (che sia economica, relazionale, simbolica, antropologica) perché il plusvalore possa macinare indisturbato, esso ha anche una capacità davvero notevole di far dimenticare le sue malefatte proiettando sugli eventi, le gerarchie e gli orrori un velo di naturalità. In questo modo, ci ha convinti che lo stato naturale del mondo fosse quello della massimizzazione dell’utile, della lotta di tutti contro tutti, dell’individuo atomico e del mors tua vita mea. Ebbene, la più grande lezione del virus è proprio quella di aver spazzato via, nel giro di poche settimane, la stantia narrazione sociale sulla quale, fino a febbraio 2020, abbiamo potuto sonnecchiare. Ha reso incredibile – nel senso di “non più credibile” – la favoletta del progresso industriale mettendoci i suoi esiti sotto il naso. Il disastro non è più a migliaia di chilometri da noi, in mezzo al deserto, in mezzo alla foresta, sul fondo degli oceani, ma corre libero per la città illuminata. Gli effetti collaterali dell’avanzata del plusvalore non riguardano più pochi selvaggi che si ostinano a non andare in fabbrica o contadini superstiziosi che rifiutano gli OGM, ma quelli che stanno ben al di qua del digital divide – e che, poveretti, s’illudono che il digital li salverà. Nel farsi catastrofe della crisi, la visione consensuale è andata in pezzi.
L’ideogramma cinese per crisi unisce due significati: pericolo e opportunità. Usando le virtù analitiche si può anche nominarli separatamente e stupire del loro accostamento, al contempo poetico e preciso; il fatto è, però, che nella crisi pericolo e opportunità non sono solo prossimi, ma si indistinguono: sono la stessa cosa. C’è opportunità perché c’è pericolo, e viceversa. Dal suo canto, l’etimologia nostrana dice che catastrofe significa “volgere”, “rovesciare”. La presenza fantasmatica degli astri nei suoni che compongono il vocabolo porterebbe a dire che una catastrofe è un rapido e pericoloso volgersi del cielo, come quando i naviganti passano da quello boreale a quello australe.
In questo cambio di cielo, nello svanire del mondo-come-lo-conoscevamo, alcuni non si lasciati fatti paralizzare dallo sgomento; non si sono chiusi dentro casa in preda al terrore; non hanno cominciato a percepire il prossimo come un pericolo; non si sono fatti intrappolare da storie stregate su sette pedofile, paladini senescenti, complotti galattici; fin da subito hanno denunciato gli elementi inquietanti delle politiche di contenimento e gli interessi che le muovono senza per questo disvedere la pericolosità del virus. Sono quelli che avevano letto e digerito, molto prima che il covid-19 le rendesse lapalissiane, le analisi critiche già a disposizione; che avevano osservato, in sé e nel mondo, la potenza di cattura della modernità capitalista; che avevano un’idea dell’esistenza sul pianeta di altri mondi umani oltre a quello governato dal profitto; che avevano una qualche presa sulle evoluzioni delle scienze, del pensiero ecologico, dell’epistemologia, dell’antropologia (inutile dire che quando il cielo si rovescia a mostrare costellazioni ignote, i naviganti che non vogliono naufragare devono subito tornare a studiare le stelle). Soprattutto, erano quelli che avevano vissuto l’esperienza fondamentale di una comunità che organizza in modo autonomo una parte almeno della sua vita collettiva, provando a uscire dalle logiche che governano le gerarchie dello stato, del plusvalore e dello spettacolo.
Carlo Perazzo fa parte di questo gruppo di umani. Credo non ci siano credenziali migliori. Poi è anche un antropologo, un libero ricercatore, un operatore in contesti ad alto gradiente di alterità culturale. Il libro che avete fra le mani traccia una pista al contempo avvertita, disciplinarmente affidabile ed eticamente tenibile, che permette, a noi oggi, di osservare quel che va accadendo sulla scena globale senza farci prendere dal panico; e, soprattutto, di tornare a vedere quel che accade sulla miriade di “scene locali” che popolano il globo di spazi vivibili, di una certa gioia, di un convenire felice di umani e non-umani.
Come tutti i migliori testi nati in questi mesi di disastro e fermento, è scritto al margine fra i futuri felici, di cui le generazioni precedenti sono state espropriate, e tutti i passati che rischiano di essere strappati alle generazioni a venire.
***
Lottare ecologicamente – di Carlo Perazzo
“Il superamento della dicotomia soggetto-oggetto è oggi determinato dall’aut-aut vita-morte; lo sfruttamento, divenuto sovrastruttura autonomizzata, cultura dello sfruttamento, è arrivato al limite oltre il quale è la fine delle risorse naturali; la prima unità realizzata tra specie umana e mondo è dunque quella degli sfruttati.” P. COPPO, Psicopatologia del non-vissuto quotidiano
“Non esiste felicità che sia solo individuale né rivoluzione che non cambi nel profondo chi la fa. S. CONSIGLIERE, Strumenti di cattura
Nel 1897 Paul Gauguin dà vita a un dipinto meraviglioso dal titolo quanto mai significativo: “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. L’opera, considerata una sorta di testamento spirituale dell’artista, affronta alcune domande da sempre fondamentali nella storia umana e che oggi, però, con un’anestesia diffusa della capacità di stupirsi e interrogarsi, sembrano aver perso presa ed essersi ridotte a un luogo comune, per lo più ignorate o al massimo poste in tono quasi canzonatorio. Domande lente e profonde, troppo grandi e complesse per trovare spazio in un mondo scandito dai ritmi frenetici della produzione e del consumo generalizzati, dove la filosofia serve tuttalpiù nelle aziende come strumento di problem solving o di abilità retorica e l’arte, compresa quella di Gauguin, è ridotta spesso a una forma pregiata e acculturata di merce.
È particolarmente significativo che da diversi mesi gruppi di attivisti e attiviste per il clima, in particolare Ultima Generazione, abbiano scelto proprio alcune famose opere d’arte come sfondo delle loro azioni dimostrative. Otto chili di farina su un’opera di Andy Warhol, una zuppa di verdure su un dipinto di Van Gogh, mani incollate a sculture di altissimo valore, sono solo alcuni esempi. Ovviamente si tratta di gesti dimostrativi e che non recano alcun danno alle opere vista la loro protezione. Ma più che il gesto, sono le domande poste dagli attivisti a essere importanti: che senso ha fermarsi a guardare la bellezza di un dipinto che come società proteggiamo sotto teca, quando allo stesso tempo stiamo deliberatamente distruggendo la vita sulla Terra? Davvero riusciamo a indignarci per la simulazione di un danneggiamento di un’opera, mentre rimaniamo impassibili di fronte alla reale distruzione quotidiana degli ecosistemi? In che modo assegniamo valore alle “cose”? Siamo ciechi, ipocriti o vittime di un incantesimo stregonesco?
Ritornando a una delle domande nel titolo di Gauguin, i militanti per il clima potrebbero rispondere che sicuramente sappiamo abbastanza bene dove stiamo andando e che la prospettiva, se una tela è più importante della Terra, è decisamente preoccupante.
Ma siamo sicuri di saper rispondere anche alle altre domande? Di sapere chi siamo, come collettività e come attivisti e attiviste, e, soprattutto di sapere da dove veniamo? Non è un caso che il pittore francese abbia posto quest’ultima come prima domanda. Il primo passaggio, allora, richiede di interrogare i molti passati, le storie, le strade percorse.
Nella stessa direzione va la bella riflessione di Irene Farronato, sul numero 03 di Epidemia: «per essere presenti e consapevoli a ciò che si fa, soprattutto in quanto militanti e attiviste, dobbiamo renderci conto di quanto profondamente i processi storici siano presenti in noi, nelle nostre pratiche, nei nostri corpi, nelle nostre idee, nell’ambiente in cui hanno luogo le nostre esperienze di vita»1. Passi indietro, quindi, e passi laterali: in una metafora cara all’antropologia, riuscire a intuire l’acqua nella quale siamo immersi e che inevitabilmente ci sfugge. Gli shock spesso aiutano a rendersi conto di ciò che si dà generalmente per scontato: è il principio delle azioni dimostrative, in cui il gesto shockante dell’attacco all’opera dovrebbe suscitare domande più profonde sul tipo di società che siamo diventati. Per esempio, senza nemmeno essere per forza ambientalisti, ci si potrebbe chiedere se non sia strano che lo stesso sistema socio-politico protegga un quadro mentre lascia morire migliaia di persone in mare o lungo i confini perché prive di un foglio di carta burocraticamente valido; e di fronte a chi si opporrebbe al paragone domandando “che cosa c’entra?”, sarebbe ora di chiedersi se davvero possiamo continuare a pensare che questo tipo di fatti non siano collegati e collegabili. Forse, così facendo, ci renderemmo conto di quanto profondo sia il meccanismo di rimozione e di evitamento che ci portiamo dentro.
Lo shock, dunque. In antropologia è lo shock “culturale”, laddove vivere mondi altri ti aiuta, al ritorno, a vedere i dettagli nascosti del “tuo”. Ma questa dinamica per dare i suoi frutti ha bisogno di una temporalità, di un inizio e una fine, di un andata e un ritorno.
Da diversi anni ormai la dimensione dello shock emergenziale e straordinario è invece divenuta strutturale e ordinaria in gran parte del mondo. Possiamo rilevare crisi in ogni ambito (economico, politico, sanitario, psicologico, ambientale, etc.) e negli ultimi tempi abbiamo assistito a una accelerazione del disfacimento di quello che ai più – e soprattutto ai più ricchi – appariva come un “ordine minimo” delle cose. Pericolosamente, lo shock è divenuto regola, inibendo così la sua funzione potenzialmente generativa.
Tanto la crisi sindemica2 esplosa attorno al Covid-19, quanto la crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, nel mettere in luce molti (pessimi) dettagli del nostro “sistema mondo”, mostrano innanzitutto l’incapacità di uscire da quel modus operandi violento che ci ha portati fino a questo tragico punto. Gli sforzi impiegati dalle istituzioni per affrontare tutte queste crisi non mostrano mai l’intenzione di un reale cambio di paradigma, ma si limitano al rilancio continuo di un sistema strutturalmente distruttivo: le risorse messe in campo hanno lo scopo di non cambiare strada e di non far fermare la macchina, nonostante questa continui a sbattere contro ostacoli che minano la vita di chi è a bordo.
Pur sapendo che il virus che ha piegato il mondo ipermoderno ha una forte relazione con la devastazione ambientale in corso, non viene messa in campo alcuna azione politica che intervenga in questo senso; allo stesso modo, di fronte all’impossibilità di reperire le risorse energetiche dalla Russia, diventata improvvisamente “nemico autocrate”, le prime operazioni messe in atto riguardano la riapertura delle devastanti e poco produttive centrali a carbone, o gli accordi per nuove forniture con altri paesi ben poco democratici, come l’Egitto di Al-Sisi, noto in Italia per le tragiche storie di Giulio Regeni e Patrick Zaki.
Sono solo alcuni esempi utili a mostrare il tunnel nevrotico dentro il quale siamo finiti come collettività, guidati da una politica che, ossessionata dal rilancio continuo di un unico modello, sembra aver perso il contatto con la realtà. Da questo shock cronico possiamo dunque partire.
Comprendere i processi storici che ci abitano e che abitano il nostro mondo significa mettere insieme i pezzi della storia stessa. Fuggendo le derive “iperspecialistiche” ed escludenti che pur dominano il presente, si tratta di costruire legami tra discipline, fatti, pratiche, teorie, di ricreare una rete laddove il mondo odierno frammenta e costruisce muri: dar vita a un dialogo tra aree apparentemente separate e, quindi, ricreare un’ecologia, un discorso e una prassi attorno alla “casa” (dal greco oikos), che non è solo uno spazio ma è anche storia, è tutto il tempo e le dinamiche vissute prima di arrivare qui, dove siamo adesso.
In questo senso intendiamo l’ecologia non tanto come “discorso sull’ambiente”, come ancora comunemente si pensa, bensì come “discorso sulla relazionalità” tra le varie parti del reale, la casa che abitiamo e che ci include. Per lottare ecologicamente crediamo si debba smettere di nascondersi dietro i muri dei “che c’entra” e tenere insieme tutto. O almeno provarci.
Proponiamo, quindi, un piccolo testo che speriamo possa essere “ecologico”, perché, se non ha la pretesa di dire molto di nuovo, cercherà almeno di mettere in relazione una serie di discorsi e spunti che spesso non si trovano vicini tra loro. La speranza è quella di trasformare molte riflessioni, che rimangono solitamente e colpevolmente dentro i muri delle accademie, in piccole sonde capaci di immergersi nel mondo “là fuori”. Scintille, provocazioni, nella speranza che tocchino qualche corda e creino qualche risonanza. Piccoli ponti, nessi tra pezzi di mondo troppo distanti, poiché crediamo che oggi la lotta per migliorare le condizioni dell’esistente non possa che essere, in ogni suo ambito, ecologica.
Il testo seguirà uno schema già piuttosto praticato e qui, per migliorarne la lettura, sintetizzato. Dopo aver “misurato la temperatura” del mondo in cui stiamo vivendo e quella nostra, proprio per mettere in luce la tossicità della quale siamo autori e vittime insieme (cap. 1), proveremo a individuare alcuni passaggi storici ed epistemologici che, a nostro modo di vedere, ci hanno portato a questo pericoloso stato febbrile (cap. 2). Una sorta di archeologia in pillole che sia in grado di mostrare quanto la frammentazione del reale sia caratteristica (nociva) della storia occidentale3. Da qui, si cercherà di portare qualche esempio di come oggi, anche in seno all’Occidente e in particolar modo nelle scienze più “dure”, emergano continue evidenze di una composizione della realtà, dell’umano e della vita diametralmente opposta, e cioè relazionale: una vita data prima di tutto in comune (cap. 3).
La scienza anticipa alcuni spunti antropologici che vanno, in un certo senso, nella stessa direzione. Questo perché pensiamo che nel mondo occidentale, proprio in quanto frutto di dinamiche storiche che ci eccedono, viviamo sulla nostra pelle l’estrema forza del paradigma “scientifico”: dall’epoca moderna in poi, infatti, le letture della realtà hanno avuto più o meno veridicità a seconda della loro validazione in sede scientifica. Ancora oggi questa dinamica è forte, tanto che per accettare alcuni presupposti fondamentali di filosofie antiche, abbiamo avuto bisogno che le scienze più contemporanee affermassero le stesse cose. Per non cadere nel vortice depressivo e paralizzante di un collasso imminente, l’antropologia proverà a offrire alcuni esempi di “possibilità altre”, altri modi di esistere, indubbiamente più sani rispetto al problema ecologico che fa da sfondo a queste pagine (cap. 4). Proveremo, infine, a proporre un’antropologia ecologica che sappia tenere insieme ontologia, epistemologia4 e politica, presentate in questo testo come indissolubilmente legate (cap. 5). Per affrontare e superare la crisi ecologica crediamo sia necessario compiere una o, forse, più rivoluzioni antropologiche; è fondamentale avere il coraggio di costruire nuovi modi di essere umani e di leggere il rapporto con il mondo che abitiamo, cominciando a trasformare il mondo che noi stessi e noi stesse siamo. Può sembrare banale, o forse un’opera spregiudicata, ma resta un passaggio che riteniamo inevitabile.
Un esercizio di sguardo in appendice proverà poi a non chiudere il discorso, accennando a sentieri ancora da percorrere sul legame tra morte, capitalismo ed ecologia. L’intento generale del testo è di proporre dei nessi utili a quella che, con Yves Citton, potremmo chiamare “controscenarizzazione”5, qui intesa come la costruzione di un immaginario, di un concatenamento di storie, che offra e stimoli pratiche e pensieri più efficaci e affini alla riproduzione della vita e delle relazioni, in radicale opposizione a quel “mito della frammentazione” che vedremo essere basilare al sistema di produzione e di governo capitalista. Come nota il teorico francese, «gli ultimi decenni si contraddistinguono per l’incapacità che ha dimostrato la “sinistra” di raccontar(si) delle storie convincenti»6. Riteniamo che questa aridità sia frutto dell’affermazione di un realismo che ben poco ha a che vedere con la struttura della realtà e che, in quanto militanti, attiviste e più in generale come umani, dobbiamo lavorare per il radicamento tanto di prassi quanto di immaginari “altri”.
Infine, una doverosa precisazione: se quasi nulla di quanto scritto è farina del nostro sacco, ciò che sentiamo nostro e che speriamo possa essere generativo è la costruzione della trama, i nessi che danno un senso più ampio ai contenuti presentati. Non pensiamo di portare una “nuova lettura del mondo”, ma solo una pratica e una proposta relazionali. Tenere insieme e far dialogare ciò che maestri e maestre7, così come pratiche ed esperienze, ci fanno scorgere e sentire qua e là. Ci pare che il nostro presente sia caratterizzato da una saturazione inquietante, che si sia diffusa una sorta di coazione a produrre e a far proliferare nuove analisi (anche nel mondo della critica) che dovrebbero aiutarci a comprendere di più e meglio i problemi che viviamo. Probabilmente questo stesso testo non è immune da queste volontà – dal tono un po’ disperato – di dire, di sapere, di convincere e di capire. Tuttavia crediamo che il problema del presente non sia tanto nella necessità di affinare ulteriormente le analisi o di inventare nuove letture: non tanto nella dimensione della conoscenza, quanto piuttosto in quella dell’attenzione e dell’accorgimento. Sfuggire a questa ossessione del nuovo per costruire ed edificare su ciò che c’è già, e che esistendo ci dimostra di essere più salutare alla vita sulla Terra, può essere un altro modo per rafforzare la speranza: molto di quello che ci serve, se non tutto, è già qui. Si tratta di essere radicali nel senso del cercare le radici: anche delle parole, laddove “inventare” (da inventus, in-venire) significa prima di tutto “trovare, scoprire cercando”, qualcosa di cui, appunto, bisogna “solo” accorgersi.
Ringraziamenti
Questo piccolo lavoro, nato dalla necessità e dal tentativo di rispondere con presenza alla violenza di questi tempi, non sarebbe stato possibile senza le “comunanze” che lo hanno sorretto e ispirato, e anche per questo è scritto utilizzando il plurale. Infinita gratitudine a chi è vita, qui, giorno per giorno, ai “magister” fraterni instancabili lettori, a chi ha dato le basi, l’incoraggiamento e la mappa, a chi ricorda l’importanza di perdersi e trovare lo sfondo e a chi non c’è più ma c’è stato, profondamente, e, in qualche modo, c’è ancora. Grazie a chi ha creduto in queste parole, trasformandole in un libro con un corpo materiale. Grazie, infine, anche a chi non perde la voglia e il coraggio di pensare e praticare altri possibili, ovunque, proteggendo la fiamma, e al percorso di Athamanta8, per essere lotta viva in questa strana terra che abitiamo.
Note:
1 Irene Farronato, I paesaggi della catastrofe. Strumenti per tessere nuove alleanze, in Epidemia 03. Cosmopolitiche. Pratiche e movimenti della transizione ecologica, 2020, p. 81.
2 Mentre la pandemia indica la diffusione di un agente infettivo in grado di colpire più o meno indistintamente chiunque e dovunque, la sindemia pone invece l’attenzione sulla relazione tra la componente biologica e quella socio-ambientale. Indica quindi non solo la relazione pericolosa tra più malattie, ma anche tra esse e la condizione economica, sociale ed ambientale delle persone. Il Covid-19, in questo senso, ha dimostrato la sua pericolosità in maniera differenziale, in particolar modo sulle persone in condizioni già svantaggiate. Si senta l’intervista di Contro radio a Sara Gandini, ricercatrice e docente di epidemiologia e biostatistica all’università statale di Milano, in https://www.controradio.it/covid-the-lancet-approccio-sbagliato-e-sindemia-non-pandemia/, consultato il 29/11/2020. Per l’articolo cui l’intervista fa riferimento si veda https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32000-6/fulltext , consultato il 29/11/2020.
3 Per quanto solo con un certo grado di semplificazione si possa dare una definizione di “Occidente”, rimandiamo al quadro che ne disegna l’antropologa Stefania Consigliere: «Una prima definizione di Occidente potrebbe indicarlo come l’asse storico-culturale che percorre e lega l’ebraismo, la Grecia classica, il cristianesimo e la modernità scientifica, coloniale e capitalista. […] Esso dispone […] di una certa coerenza tassonomica conferitagli da un insieme di elementi che hanno un’aria di famiglia e si ritrovano oggi in modo ubiquo, sedimentati e variamente combinati, quasi sempre attivi: il monismo ontologico (che si declina anche in monoteismo); l’essenzialismo; l’esigenza di universalità; il prestigio della dimostrazione; il risalto dei termini individuali atomici anziché della relazione tra di essi; il risalto tutto tondo dell’individuo rispetto allo sfondo; la superiorità accordata alla vista; la propensione a privilegiare la razionalità deduttiva e la ragione strumentale; l’integralità del bene; il tempo lineare; la progressione evolutiva dei processi; […] la percezione degli esseri secondo una gerarchia di valore; il nesso scarsità-valore; l’enfasi sull’attività cognitiva e sulla sua regolatività rispetto a ogni funzione psichica; la verità come rappresentazione fedele dello stato delle cose nel mondo», in Antropo-logiche, Colibrì, 2014, p. 42.
4 Ovvero il modo in cui concepiamo il nostro e l’altrui essere e, più profondamente, la realtà tutta, e il modo in cui la leggiamo e conosciamo.
5 Citton utilizza il termine “scenarizzazione” per riflettere attorno al legame tra pratiche narrative e dispositivi di potere. Si veda Yves Citton, Mitocrazia. Storytelling e immaginario di sinistra, Alegre, 2013.
6 Ivi, p. 22. Si veda anche Stefania Consigliere, Favole del reincanto. Molteplicità, immaginario, rivoluzione, Derive approdi, 2020, in particolare pp. 78-79.
7 In particolare, tutta la nostra profonda gratitudine va a Stefania Consigliere, Piero Coppo, Gregory Bateson, Raimon Panikkar, Tim Ingold e Chandra Livia Candiani; al loro continuo sforzo di provare a leggere il reale con occhi critici ed ecologici.
8 Athamanta è un percorso nato nel 2020 a Massa-Carrara, uno spazio di discussione, autorganizzazione e sperimentazione politica intorno al tema dell’ecologia e della difesa della Alpi Apuane. Si veda https://athamanta.wordpress.com/.
Immagine: G. Klimt, Melo 1.