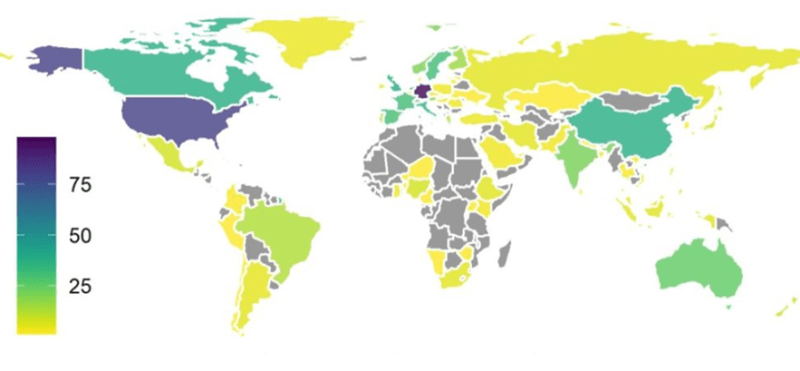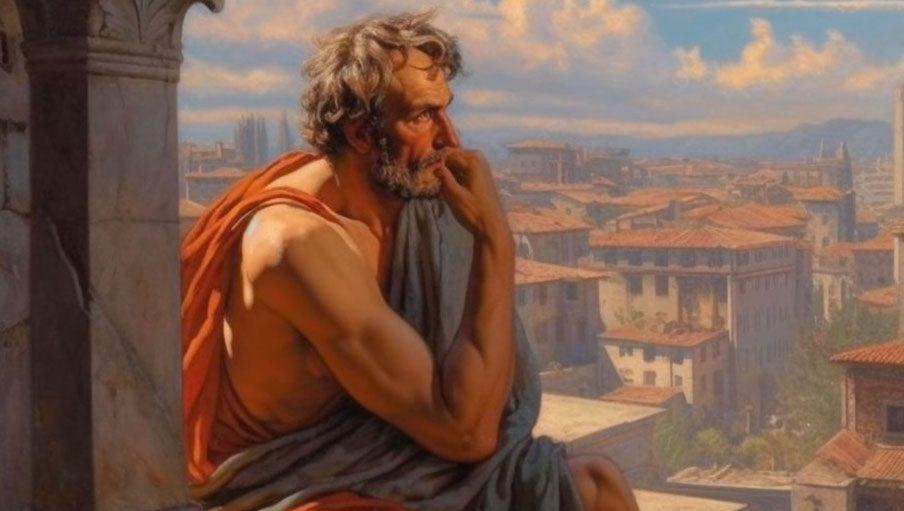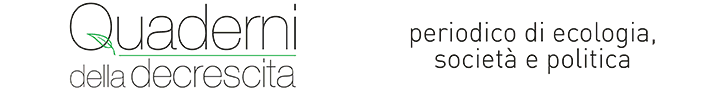Giovanni Mazzetti, in occasione di un incontro pubblico a Roma con Maurizio Pallante, ha pubblicato un opuscolo, Critica della decrescita, Quaderno n. 1, Progetto Altro Formazione [in seguito pubblicato con lo stesso titolo per le Edizioni Punto Rosso, Milano, 2014], ed ha allegato il Capitolo n. 13 del suo libro: Quel pane da spartire (Bollati Boringhieri, 1997), in cui l’autore svolgeva una serrata critica a André Gorz. In seguito Paolo Cacciari ha scritto una lettera di commento a quello scritto, a cui Mazzetti ha a sua volta replicato con uno scritto intitolato “I rovi nei quali è impigliato il movimento della decrescita”. Data la serietà e l’interesse di questo confronto pubblichiamo l’intervento di Paolo Cacciari e la successiva risposta di Giovanni Mazzetti.
Paolo Cacciari
Mazzetti spazia – a ragione – in molti campi. Antropologia, storia, sociologia, politica, oltre che economia. E non potrebbe essere altrimenti. La “decrescita”, anche se fosse solo uno “slogan” (e non – come io credo – molto di più, a dispetto del suo maggiore promulgatore!), dovrebbe spiegare in qualche modo il suo successo presso un vasto pubblico. Secondo Mazzetti tra i sostenitori della decrescita (lui li chiama – malamente – “decrescisti”) ci sarebbe una buona dose di ingenuità e stupidità. Ma, per fortuna, il suo scritto non trascende (quasi) mai in una polemica sterile. La sua statura culturale è tale che meriterebbe una interlocuzione. Io non posseggo certo tutti gli strumenti necessari per confrontarmi con il suo scritto. Comunque, con molta modestia e approssimazione, mi piace tentare di confrontarmi con alcune questioni che ha sollevato. Anche perché in Pensare la decrescita (Carta e Intra Moenia, 2006), avevo tentato di aprire un confronto con la cultura della sinistra del movimento operaio (da cui provengo e di cui Mazzetti è certo un non secondario punto di riferimento). Allora – facendo sorridere Serge e indispettire Maurizio – avevo tentato di dimostrare che “verde” e “rosso”, che le ragioni della sostenibilità ambientale e quelle della equità sociale potevano trovare nel marxismo qualche ragione di componimento e che la critica al progetto di sviluppo capitalistico aveva già trovato in Claudio Napoleoni un punto solido di appoggio. Mi pare giusto ricordare anche gli scritti di Fabrizio Giovenale, Carla Ravaioli e di Virginio Bettini. Più recentemente è arrivato lo scritto di Bontempelli e Badiale, Marx e la decrescita, che mi ha tirato molto su il morale. Infine, Gustavo Estava sta dicendo nelle sue conferenze che Illich non solo aveva bel letto Marx, ma che è possibile trovare tra i due nessi coerenti (“Dal mio punto di vista, Illich ha costruito le sue idee su Marx. Ha cominciato dove Marx finiva, seguendo la direzione del pensiero di Marx. Non vedo, in Illich, nessuna idea radicalmente distante dalle posizioni teoriche e politiche di Marx. Gustavo Esteva, Crisi sociale e alternative dal basso.Difesa del territorio, beni comuni, convivialità).
Veniamo quindi a noi. Mazzetti ricorda di aver già criticato a suo tempo uno dei principali ispiratori della decrescita, André Gorz, oltre che Guy Aznar (Lavorare meno per lavorare tutti). L’impressione che ricava Mazzetti è che tutti (Illich, Gorz, Aznar, Latouche, Pallante, Badiale) pecchino di astrattezza, mancanza di praticabilità, di ideologizzazione. I sostenitori della decrescita non terrebbero per niente conto delle circostanze, di vincoli strutturali e psicologici, delle prassi sociali consolidate, delle necessità introiettate dalle persone, delle limitate possibilità reali di scelta che hanno i singoli individui immersi, come sono, nei rapporti produttivi e sociali esistenti.
Per cambiare le cose non basta gridare: Non mi piace vivere in questo modo!. Non basta cercare di allargare l’immaginazione. Bisogna realizzare trasformazioni continue tanto delle strutture delle relazioni sociali quanto della natura umana desiderante. Le catene non sono solo mentali (condizionamenti ideologici), sono anche psicologiche (agiscono in profondità sulla volontà degli individui che si fanno “servi volontari”) e concrete (costrizioni economiche).
Scrive Mazzetti molto bene: “Come sottolinea Marx in molti suoi scritti: il processo di trasformazione delle circostanze finisce in tal modo col coincidere con il processo di autotrasformazione degli individui. Essere individuale ed essere sociale cambiano dunque simultaneamente, e anzi l’individuo cambia solo se riesce a mutare il suo stesso essere sociale, cioè la struttura delle sue relazioni, conquistando una libertà nuova”.
Fin qui, per parte mia, mi pare di poter condividere le argomentazioni di Mazzetti. Gli “spazi di libertà” si conquistano solo nella pratica di lotta quotidiana contro le innumerevoli forme di soggezione, eteronomia, dominazione, alienazione, ecc. che caratterizzano le organizzazioni sociali (non solo quelle capitalistiche e non solo quelle moderne; basti pensare – e pochi lo fanno – alle discriminazioni di genere originate da 5.000 anni di patriarcato).
Accetto, quindi, anche la critica (e non è solo Pallante il bersaglio) alla idealizzazione delle presunte “comunità originarie”, “organiche”, “microsociali” e delle fasi arcaiche edeniche che avrebbe vissuto l’umanità. Non ci sono Paradisi Perduti di cui avere nostalgia. Gli studi delle antropologhe femministe (e della Carolyn Merchant, La morte della natura) possono soccorrerci nel ritrovare una visione ampia e profonda dell’evoluzione della cultura umana. Quindi, siamo tutti d’accordo con Marx: “La storia tutt’intera non è che una trasformazione continua della natura umana”. Non c’è nulla di predeterminato biologicamente, così come non vi è un determinismo storico lungo il quale si svolge l’evoluzione umana. Ma con questo?
Chiedo a Mazzetti: ci piace la costruzione storica contemporanea cui è giunta l’umanità? Pensiamo che nel corso della storia gli eventi avrebbero potuto prendere altre direzioni? Ci è consentito cercare di influenzare il futuro in un modo diverso da quello inerziale, businnes as usual?
Non credo che il tautologismo secondo cui la realtà esistente è quella prevalente, per cui quello che viene dopo è sempre meglio di quello che viene prima (secondo un malinteso principio di realtà), non ci possa autorizzare a pensare e affermare che alti mondi sarebbero stati e saranno possibili. Sono sicuro che anche Mazzetti la pensi così e sia dalla parte di chi vuole cambiare il mondo. Le ragioni che ci ispirano sono comuni, essenzialmente: insostenibilità ambientale e ingiustizia sociale.
Le differenze (probabilmente profonde e importanti) con Mazzetti sono su cosa dobbiamo salvare del vecchio mondo (è noto che gli ambientalisti tendono a non buttare via nulla e a riciclare il più possibile!) e su cosa fare per cambiare. Che poi è un problema di giudizio storico (quindi di valori etici da mettere in campo) e di progetto politico (soggetti che li sostengono e che sono disposti a praticarli).
La prima diversità di giudizio che mi balza agli occhi è l’idea positiva che Mazzetti attribuisce alla separazione uomo/natura (consacrata dalla rivoluzione scientifica cartesiana-newtoniana) con la conseguente “trascendenza” dell’uomo (qui propriamente inteso come bianco, occidentale, adulto) dalla sua entità immediatamente naturale. Mi appello e rimando alle riflessioni di F. Capra (che pure non ama il termine “decrescita”) sulla storia della scienza e sul fatto che probabilmente Leonardo Da Vinci (fautore di una sintesi tra amore e conoscenza) ci avrebbe schiuso prospettive diverse da quelle invece storicamente prevalse. Ma, sicuramente, l’origine dell’idea di un uomo vicino a Dio perché dotato di poteri di dominio sulla natura (da cui la separazione tra razionalità e sentimenti, tra spirito e corpo, uomo e donna….) e di una sconfinata hibris, viene da ancora più lontano. A me (e a molti altri) pare indubbio che questa visione andro e antropocentrica tipica della cultura occidentale sia la causa di quel disconoscimento dell’unità della vita, di quella rottura del rapporto uomo/natura che tanti guai ci sta comportando.
Non pretendo che nessuno condivida queste tesi, ma che almeno le riconosca come plausibili, interessanti e fondate. Ciò che mi colpisce di Mazzetti (e non solo di lui) è la mancanza di una visione non dico cosmica, ma almeno planetaria (avrebbe detto Ernesto Balducci) dei fatti del mondo. Altrimenti come facciamo a riconoscere l’introduzione di Pacha Mama nella costituzione Ecuadoregna, i movimenti indigeni latinoamericani, le rivolte “maoiste” dei contadini in India, le resistenze africane… fino ai movimenti per i nuovi commons in Occidente, i 26 milioni di voti sul referendum sull’acqua in Italia?
La seconda diversità di opinione è (nientemeno) sul giudizio di valore da dare al capitalismo. Mi pare di capire che Mazzetti prenda per buona la idea di un Marx abbagliato dalle magnifiche e progressive sorti del capitalismo, quando cita il VI Capitolo inedito del Capitale: “…l’inesorabile sviluppo di quelle forze produttive che sole possono fornire la base materiale di una libera società umana…”. Quindi, non solo sarebbe inevitabile il “rapporto di merce” (compresa la terra, il lavoro umano e la moneta), ma esso costituirebbe un “fatto culturale positivo”, una prima forma di “integrazione” e di “legame tra gli esseri umani”. Mi permetto di dire che molti storici (e Marx stesso) hanno visto nelle enclosures e nella “accumulazione originale” (che è diventata permanete) una gigantesca forma di violenta distruzione dei legami sociali, di espropriazione dei commons (usi civici e proprietà collettive) e di formazione di un esercito di diseredati impoveriti alle porte di ogni opificio.
Mi permetto di dire che la ricostruzione storica di Mazzetti della rivoluzione industriale (“la tendenza spontanea delle masse, i cui rapporti si stavano disgregando, era quella di riversarsi nel vagabondaggio, nella mendicità e nel brigantaggio”) non è quella oramai prevalente tra gli studiosi marxisti (David Harvey, Peter Linebaugh).
Riprendo una frase di Gustavo Esteva: “La storia del capitalismo è la storia di una guerra continua contro la sussistenza autonoma. Iniziata con la recinzione (enclosure) dei commons, non si è mai interrotta, anzi l’operazione si è intensificata nel periodo neoliberista, con quelle che sono state chiamate le new enclosures, le nuove recinzioni”.
Comunque, rimane il fatto che nessuno ha chiesto ai commoners di ieri, come ai contadini meridionali italiani così magistralmente descritti da Carlo Levi, o a quelli indiani e cinesi oggi, cosa avrebbero preferito fare: gli schiavi nelle manifatture o i contadini, poveri, ma non immiseriti, nelle terre comuni. Il fatto che la proprietà privata esclusiva della terra (suolo, acqua e giacimenti minerari) e dei beni fondamentali al vivere dignitoso abbia aumentato le rese e la produttività (a favore dei capitalisti) non giustifica che ciò sia avvenuto grazie al sacrificio di sterminate masse di contadini espropriati, proletarizzati, salarizzati. Mi pare che le evidenze storiche stiano a dimostrare che sia solo una terribile illusione la promessa del mercato di far accedere i lavoratori subordinati a generi di consumo di massa come compensazione della perdita di autonomia, autodeterminazione, spazi di autodeterminazione. Le “Zone produttive speciali” per l’esportazione in Asia, in Africa, in America latina sono gulag di massa al servizio dei consumi occidentali.
Ora io credo che una attenta analisi storica non solo occidentale-centrica ci dimostri che, certamente, da un lato i modi di produzione capitalistici (propriamente la divisione tecnica del lavoro) hanno aumentato oltremisura (oltre ogni ragionevole limite e ogni capacità di controllo) gli strumenti tecnici a disposizione del genere umano, ma che i benefici non siano alla portata di tutti gli individui e che la loro controproduttività (per dirla con Illich) sia tale da mettere in discussione la sopravvivenza stessa del genere umano (in particolare di quella parte che non ha beneficiato mai dell’“inesorabile sviluppo delle forze produttive”).
Una più attenta e articolata lettura di Marx potrebbe forse aprire scenari più articolati sul suo pensiero. Ma, a prescindere da Marx – se mi è concesso! – chiedo: diminuire i flussi di materia e di energia impegnati nei cicli produttivi e di consumo, dare il tempo e il modo ai “servizi ambientali” (cioè ai cicli vitali della biosfera) di rigenerarsi evitando di impoverire in modo irreversibile gli stock dei beni naturali limitati esistenti nel nostro pianeta è un obiettivo umanamente concepibile, desiderabile, praticabile, persino utile e razionale?
Io penso che rimanendo all’interno di una logica capitalistica (di quelle “circostanze” e di quelle “prassi sociali”, cioè di quei sistemi di potere, di cui parla Mazzetti) sia impossibile raggiungere una accettabile armonia tra conservazione di una accettabile qualità ambientale e benessere generalizzato di tutti gli esseri umani La logica capitalistica (di tutti i capitalismi immaginabili) è ferrea: profitti, accumulazione, valorizzazione monetaria. I cui sottostanti sono: espropriazione ed “estrattivismo” dei beni comuni dell’umanità, sfruttamento e alienazione del lavoro, concentrazione del potere economico e dominazione.
La diversità con Mazzetti è allora sul concetto di “razionalità economica”. E qui mi piacerebbe che Mazzetti si confrontasse con la critica che Gilbert Rist (I fantasmi dell’economia) formula alla “scienza economica” e al concetto di “sviluppo”. Non in astratto (come se fosse un modo di dire equivalente a progresso, benessere, sviluppo umano, ecc.) ma come concretamente è nato, entrato nel linguaggio economico e politico e come si è storicamente determinato (negli Stati Uniti vincitori nel secondo dopoguerra) e usato correntemente da governatori e analisti economici esattamente come sinonimo di crescita economica. E non potrebbe essere altrimenti: se nel senso comune (di dx e sx, dei governi conservatori come di quelli progressisti, di Berlusconi e di Prodi/Monti/Renzi, della Merkel e di Shultz) il bene pubblico e l’interesse generale si identificano nel produrre, vendere, consumare di più (cioè aumentare il Pil), allora è inevitabile che non si faccia più distinzione tra crescita economica (del volume del valore delle merci in circolazione) e sviluppo. Reintrodurre questa distinzione (così come inserire qualche altro indice di valutazione della ricchezza e del benessere, come tentò inutilmente la Commissione dei Nobel voluta da Sarkozy) sarebbe già un passo avanti, ma la “razionalità economica”, cioè il senso comune politico dominante impedisce anche solo questa articolazione semantica del discorso.
Non siamo noi, quindi, caro Mazzetti, che non vediamo una differenza teorica tra crescita del Pil e sviluppo umano, ma il cieco totalitarismo della “scienza economica” dominante.
C’è una razionalità intrinseca al rapporto di produzione capitalistico che è quello del continuo, perpetuo aumento delle rese e della produttività. Ma c’è un’altra razionalità (che sarebbe meglio chiamarla ragionevolezza) che riguarda le risposte da dare alle domande di senso: cosa, come, dove, per rispondere a quali bisogni e per chi produrre.
E veniamo alla questione politica centrale. Si chiede Mazzetti: “chi decide quali sono le merci utili?”. Visti i fallimenti del mercato (presunta capacità auto-regolativa di garantire l’equilibrio non solo tra domanda ed offerta di beni di consumo, ma anche tra stock e flussi di servizi ambientali naturali) bisognerà trovare dei meccanismi diversi. (Per pudore non parliamo dei meccanismi che hanno tentato di introiettare i costi ambientali e mercificare prelievi e inquinamenti. Vedi Kyoto).
Non nego (anzi, ne ho scritto più volte) che vi sia una decrescita “di destra” che pensa ad una nuova elite di sapienti, una nuova tecnocrazia di esperti ambientali (“colonnelli verdi” li chiamavamo negli anni ’80!) che vorrebbe sostituirsi alla tecnocrazia oggi al potere (quella degli economisti) e che decide per tutti.
Non è questa la idea di Illich, Gorz, Latouche e nemmeno, voglio credere, quella di Pallante.
La decrescita attiva, scelta, selettiva, mirata… è un processo di massa, popolare di identificazione dei problemi cruciali del mondo e, contemporaneamente, di attivazione concreta di donne e uomini che lottano (non so trovare altro verbo, potremmo dire: faticano) per dimostrare che un altro modo di vivere, produrre e consumare è possibile.
Il fatto nuovo e vero (quello che testimonia le sale piene alle conferenze di Serge e Maurizio, le centinaia di Gas, di banche del tempo, di orti sociali, di sistemi di scambio non mercantili…) è che queste persone ci sono già. Non serve inventare a tavolino dei soggetti. Sono individui che si sono soggettivati già da soli. Hanno le loro organizzazioni (pensiamo a Via Campesina, la più grande organizzazione contadina del mondo e ai Sem Terra in Brasile), le loro modalità di relazione (pensiamo all’equo e solidale), i loro stili di vita (pensiamo al vegetarianesimo e al veganesimo, ai Bilanci di giustizia)… e così via. Mi si dirà: “sono nicchie” per anime belle, fricchettoni, pauperisti francescani. Attenzione però: uno l’hanno fatto papa! E non vorrei che le capacità camaleontiche della Chiesa cattolica fossero più avanti di quelle teoricamente e politicamente più strutturate della sinistra secondo la quale gli uomini e le donne “in carne ed ossa” sono solo quelli che si accalcano agli ipermercati, che frequentano le curve degli stadi, che non leggono un giornale, decerebrati seduti davanti alla televisione e così via. “Rude classe pagana”, la chiamava con orgoglio un raffinato intellettuale operaista, Mario Tronti. Secondo la sinistra concreta e pragmatica l’offerta politica vincente deve rivolgersi a questa tipologia umana. Non possiamo shoccarla dicendole di non mangiare carne per non far soffrire gli animali, di non comprare Nike per non sfruttare il lavoro minorile, di spegnere la televisione… Non possiamo nemmeno dirle di diminuire il tempo dedicato al lavoro (eteronomo, salariato, mercificato) fino a che la sua esistenza dipende esclusivamente dal salario che riesce a portare a casa. Ecco, a me sembra che il bagno di realismo, gradualità, “lunga marcia” dentro le istituzioni economiche e politiche… che Mazzetti ci invita (giustamente) a fare rischi di tagliare le ali e le gambe dei movimenti altermondialisti, anticapitalisti, ecosocialisti… a dir si voglia, se non si accompagna contemporaneamente ad una chiara prospettazione di un oltre e di un fuori le gabbie del rapporto sociale capitalistico, cioè del rapporto di dipendenza del lavoro.
Forse è la solita storia della contrapposizione tra rivoluzionari e riformisti che riappare in continuazione. Ma con una differenza – almeno da parte mia. Non escludo che sia giusto praticare tutte le forme di “diminuzione del danno”, di redistribuzione del lavoro e della ricchezza a favore dei ceti e delle popolazioni più deboli (usando, per quello che si può, anche le istituzioni statali), ma se queste lotte non si proiettano in un orizzonte di senso alternativo (cioè etico: “la capacità di distinguere il bene dal male deve ogni volta essere sviluppata attraverso l’esperienza” scrive giustamente Mazzetti a pag.19), rischiano di non produrre alcun effetto sostanziale.
In altri termini a me pare che sia giusto tentare di ridare lo scettro alla politica (ridimensionando le logiche di mercato), ma per riuscirci la politica deve acquistare un connotato di senso etico. Deve avere – come dicono i latinoamericani – una cosmovisione alle spalle.
Capisco bene che il discorso della decrescita può apparire persino offensivo per chi non ha nemmeno il “necessario” (inteso in senso esteso come “ciò di cui non si può fare a meno”, come dice giustamente Mazzetti, comprendendo non solo la sopravvivenza, ma anche il superfluo, se questo è giudicato dai singoli individui una connotazione di status – vedi il telefonino, le scarpe firmate, ecc.) e che bisogna fare ancora moltissimo per dimostrare con i fatti che lo slogan “vivere meglio con meno” può essere vero. Ma questa è la ragione per cui la decrescita va concepita a tutto tondo: non solo come diminuzione fisica dei flussi di materia impiegati nei cicli produttivi, ma come un più grande e generale processo di liberazione da ogni forma di dipendenza e di eteronomia. In questo – concordo con Badiale – vedo la decrescita molto vicina al marxismo rivoluzionario.
Scrive Mazzetti: “Traspare la componente anarchica del pensiero dei sostenitori della decrescita, i quali contro tutte le evidenze scientifiche, negano sotterraneamente la nostra natura originariamente animale, e sono privi di difese rispetto alla concezione settecentesca che rappresentava l’uomo originario buono per natura, e la cui bontà sarebbe stata corrotta dalla civiltà” (p.19).
Come ho cercato di dire, ogni riferimento al “segreto della natura umana” rischia di essere un terreno molto scivoloso. Probabilmente la natura umana (e non solo quella) nasconde più di un segreto, che sarebbe bene riconoscere con un grande senso di modestia e un utile principio precauzionale. Edgar Morin (che vorrei inserire di diritto tra gli ispiratori del pensiero della decrescita) scrive che è sbagliato separare natura e cultura: siamo al 100% esseri culturali e 100% esseri naturali, 100% razionali e 100% sentimentali. Così come sono fermamente convinto che Tolstoj e Gandhi siano i profeti del pensiero della decrescita. Analizzando tutte le religioni apparse sulla faccia della terra giunsero alla conclusione che sia iscritto nelle facoltà di ciascun individuo umano il dispositivo di “non fare al tuo prossimo ciò che non vorresti lui facesse a te”. O, per meglio dire ancora, con Matteo: “fa all’altro ciò che vorresti facesse a te”. Così come credo sia iscritto nella coscienza e nella mente e nel cuore e nel cervello… di ognuno la capacità di distinguere il bene dal male, che persiste persino nella mente dei nazisti descritta da Hannah Arendt, così come in quella degli internati descritta da Primo Levi. Ciò non significa che tutti siamo buoni (che ci comportiamo “naturalmente” bene), ma che potenzialmente lo potremmo essere. Certo, Franco Cassano ci ha spiegato la forza di penetrazione del male nella sua capacità di far leva sulle debolezze umane (è più difficile essere generosi che taccagni, egoisti che altruisti…). Io penso che lo sforzo di ognuno e di tutti (cioè della politica) sia quello di far emergere questa potenzialità. La “scienza economica”, al suo nascere (quando si è data uno statuto apparentemente oggettivo, mutuato dalle scienze naturali), viceversa, ha decretato per l’essere umano uno statuto esclusivamente e necessariamente egoista e individualista. Noi, decrescenti, commoners, socialisti, comunisti… diciamo invece che in ognuno di noi c’è anche un lato altruista, generoso, solidale, cooperativo, ecc. ecc. che andrebbe liberato e maggiormente sviluppato. Tentare di essere più buoni (fare meno male possibile al prossimo, essere individui coscienti e responsabili delle conseguenze delle proprie azioni, non essere corresponsabili della distruzione del pianeta…) non è un peccato! Ho trovato scritto da qualche parte che la generosità è l’energia rinnovabile dell’universo umano così come le stelle lo sono per l’universo fisico.
Orami abbiamo capito che la filosofia di vita thatcheriana-reaganiana (e, prima di loro, la “nuova frontiera” kennedyana) – arricchitevi, consumate, fatevi gli affari vostri e della impresa per cui lavorate… – non ci ha portato molto lontano.
Ma tant’è, Mazzetti ci dice che per una “moltitudine di individui” non ci sono alternative pronte, non ci sono altri modi per sbarcare il lunario se non “entrare nel circolo produttivo prevalente (e) non precipitare nell’inedia (disoccupazione). E se cercavano di entrare in quel circolo attraverso la vendita della propria capacità produttiva era perché non sapevano farlo con un’altra modalità sociale! Se oggi in Europa ci sono più di 25 milioni di disoccupati che manifestano rivendicando ‘lavoro, lavoro’ e non procedono secondo le aspettative di Pallante, è perché quella del lavoro salariato è diventata la forma normale di partecipazione al processo produttivo e riproduttivo”. Insomma: TINA. Poiché non sono pronte alternative.
“Ritenendo ininfluente l’essere merce della forza-lavoro, e considerando il lavoratore salariato non come membro di una classe, ma come un individuo già pienamente maturo, cioè libero in generale, egli (Gorz) finisce con l’attribuirgli una capacità di appropriarsi del tempo reso superfluo prima che intervengano gli stessi processi che soli possono mediare realmente questa appropriazione”.
Quindi, l’unica cosa che possono fare disoccupati, inoccupati e lavoratori di ogni genere è dividersi tra loro il lavoro e la ricchezza che la megamacchina produttiva riesce a generare attraverso un forte intervento statale. Le teorie keynesiane sono l’orizzonte massimo consentito nella situazione data.
Ma il compromesso capitale-lavoro ha funzionato solo in una relativamente piccola parte del pianeta e, comunque, ora non funziona più nemmeno in quella. La terribile sensazione di essere asserragliati in una cittadella assediata ha preso il posto a quella dei gloriosi trenta anni di espansione che sembrava infinita, ammirevole e ammirata da tutti.
Al fondo ancora ciò che divide i decrescenti dai neo-keynesiani di sinistra è il giudizio sulla crisi attuale. Una crisi non solo di fase e strutturale, ma multidimensionale e sistemica, “cognitiva” (dice Morin), cioè di civiltà. Se le teorie di Keynes (e le politiche socialdemocratiche) erano riuscite a salvare il capitalismo (evitandoci guai maggiori, a giudicare dalle parabole del “socialismo reale”), oggi, a me sembrano, armi spuntate. Non vedo grandi margini per nuovi piani Marshall. Non vedo nuove frontiere da colonizzare, non vedo stili di vita invidiabili nell’ex Primo Mondo.
Ma rimane la sfida che ci lancia Mazzetti (e non solo lui): “Per affrontare i problemi causati dalla crescita non basta negare la crescita, rappresentarla come una sventura, occorre piuttosto sviluppare capacità nuove che riconducano le forze produttive acquisite nell’alveo di un nuovo modo di produrre”.
E qui si apre il campo vasto e ampiamente inesplorato dell’ “economia solidale” (Jean Lous Laville), partecipativa (Michael Albert), sociale, civile (Zamagni), collaborativa (Labsus), della condivisione (Joseph Kumarappa), del no profit, “del noi” (Roberta Carlini), informale, del bene comune, dei commons (“commodomics”, che allude alla amministrazione dei beni comuni, come suggerisce Raul Zibechi), del bastevole e del sufficiente (Wuppertal Institute), dell’economia plurale (NEF)… dell’“economia morale” (Illich).
Stiamo parlando della sfera delle attività umane che contemplano uno scambio economico (comprese transazioni commerciali, contrattate, monetarie), così come l’uso di strumenti che potenziano la forza fisica e la creatività umana , ma che sottostanno a principi discriminanti quali la reciprocità, la cooperazione, l’autogestione, la proprietà condivisa, l’equilibrio tra le mansioni di responsabilità e di routine, la responsabilità sociale e ambientale e così via. Insomma la fuoriuscita dal produttivismo e dal consumismo e la creazione di “comunità del fare in comune” integrate in sistemi di relazioni umane (territoriali e di filiera) rispettose degli scopi dell’agire umano.
In questo senso ci può stare anche l’idea di una “economia della decrescita”, intesa non come un’altra economia, ma una alternativa alla società dell’economia.
Un caro saluto,
paolo
Dolo, 10 luglio 2014
Giovanni Mazzetti
Sono molto contento che Paolo Cacciari non abbia fatto come molti dei miei interlocutori di sinistra negli ultimi decenni[1]: indispettiti dalle critiche, invece di reagire con delle controcritiche, hanno puramente e semplicemente confidato sull’indifferenza e sulla sovracomunicazione dilaganti, tornando a ribadire argomentazioni e tesi delle quali avevo cercato di dimostrare l’insostenibilità. Cacciari ha invece preso seriamente in considerazione i miei motivi di dissenso dalla cultura del movimento della decrescita, nel quale si schiera con una sua propria collocazione, criticandoli. Così si può sperare di fare qualche passo avanti nell’elaborazione di una strategia politico-culturale, bloccando i continui arretramenti di cui siamo vittime.
1.
Prima di entrare nel merito delle questioni che solleva vorrei rappresentare con una metafora il senso generale della mia posizione. Chi ha l’abitudine di avventurarsi in campagne non troppo frequentate sa che spesso, in quelli che sembrano sentieri percorribili, si presentano all’improvviso boschi di rovi che ostacolano il cammino, perché quei percorsi sono stati abbandonati. Quasi sempre ciò costringe a cercare un altro sentiero, anche se questa ricerca comporta una qualche frustrazione. Chi pretende invece di penetrare in quei rovi convinto che presto arriverà dall’altra parte, scoprirà che gli è impossibile procedere e sarà costretto a fermarsi. La mia critica dei sostenitori della decrescita è, appunto, che essi non si rendono conto dell’intrico nel quale sono piombati e nel quale pretendono di andare avanti.
Molto spesso chi sta camminando non si trova nella situazione di poter valutare subito l’estensione del bosco di rovi, e all’inizio l’impresa può sembrargli abbordabile. Ma è già a questo livello che è necessario accorgersi di quello che sta succedendo, perché altrimenti una volta entrati si finisce quasi sempre con lo smarrire l’orientamento.
Penso, ad esempio, che le domande con le quali Cacciari inizia il suo confronto dimostrino già il sussistere di questo rischio. “Chiedo a Mazzetti”, scrive, “ci piace la costruzione storica contemporanea cui è giunta l’umanità?” E subito dopo: “pensiamo che nel corso della storia gli eventi avrebbero potuto prendere altre direzioni?”. Per concludere: “ci è consentito cercare di influenzare il futuro in un modo diverso da quello inerziale?”. Io qui avrei cominciato ad essere cauto, perché si tratta di rovi che non possono essere districati con facilità. Il problema non è, infatti, se la formazione sociale nella quale siamo immersi ci piaccia o non ci piaccia, ma se essa sia coerente o in contraddizione con il grado di sviluppo raggiunto dall’umanità e con i bisogni che lo caratterizzano. La convinzione che “le forme del contesto sociale si contrappongano agli individui come un loro strumento”(Marx), e che dunque possano essere scelte[2], è un’illusione che emerge con la società borghese e che esprime i limiti di questa formazione sociale, nella quale la maggior parte delle persone sa poco o nulla di come lo sviluppo umano è intervenuto e potrebbe procedere. Personalmente sostengo da tempo (da più di vent’anni) che sia i rapporti capitalistici, sia la prima rozza forma del loro superamento rappresentata dal Welfare keynesiano, abbiano dato tutto ciò che potevano dare. E proprio perché hanno cambiato positivamente il mondo, sono diventate contraddittorie; cioè spingono per un loro superamento. Ritengo anche che se non saremo capaci di attuare questo cambiamento un regresso sociale peggiore di quello che stiamo già subendo sarà inevitabile Ma qui è dove cominciano i guai, perché l’alternativa non è già data, bensì costituisce un problema. Un problema che, a mio avviso, la cultura della decrescita rimastica molto maldestramente.
Non basta infatti voler “influenzare il futuro in modo diverso da quello inerziale” per ottenere i cambiamenti che si spera di attuare. Poiché la società non è un qualcosa di statico ed ha già una sua propria energia evolutiva e una direzione a cui tende, bisogna sapere interagire con quella dinamica in maniera corrispondente sia alle condizioni date che al cambiamento voluto. Come scrive Marx nei Grundrisse, “se non trovassimo nella società così com’è le condizioni per i cambiamenti che vogliamo attuare, i nostri non sarebbero altro che sforzi donchisciotteschi”[3]. Da questo punto di vista non me la sento affatto di far precipitare nel calderone negativo, come fa Cacciari, un problema del passato come quello “delle discriminazioni di genere originate da 5000 anni di patriarcato”. Una simile critica è concepibile solo se si proietta nell’antichità la moderna individualità, fondata sull’uguaglianza e su una relativa possibilità di “scegliere” il proprio ruolo, e si nega tutta la complessità e la ricchezza insita nelle discriminazioni (distinzioni) di genere attuate in epoche passate. Credo che esseri umani, che allora consideravano il mestruo e il concepimento come un qualcosa di sacro e di misterioso, non potessero procedere diversamente da come hanno fatto, aiutandoci – certo molto rozzamente – a riconoscere la differenza tra un uomo e una donna senza dover continuare a farlo attraverso le reazioni istintive scatenate dagli odori dei periodi fecondi.
Quindi, se concordo con Cacciari che una trasformazione della realtà sociale è non solo possibile, ma anche necessaria, non mi illudo sull’esistenza di molte possibilità, ma solo di qualche ristretta opportunità, che non può essere definita troppo genericamente senza correre il rischio di farla andare sciupata. Per questo ho sempre criticato il superficiale sincretismo del Partito della Rifondazione Comunista, quando questo ancora sembrava cercare una strada.
2.
Il secondo punto sollevato da Cacciari è più complesso perché cade in una contraddizione logica non troppo evidente. Egli appare stupito del fatto che io coltivi “un’idea positiva della separazione uomo/natura” che, a suo avviso, implicherebbe una “conseguente trascendenza dell’uomo … dalla sua entità immediatamente naturale”. Sarebbe questa “visione andro e antropocentrica … la causa di quel disconoscimento dell’unità della vita, di quella rottura del rapporto uomo/natura che tanti guai ci sta comportando”. In questa critica del mio pensiero c’è troppo e troppo poco. Innanzi tutto se l’umanità può essere considerata come un valore è appunto perché gli esseri umani non sono “immediatamente natura”. Se si rovescia questo valore, elevando la natura al di sopra dell’essere umano per come si è grossolanamente realizzato con lo sviluppo, non si riconosce che la natura – a meno che non la si idealizzi proiettando in essa l’umano valore di una sua presunta superiorità – non è depositaria di valori. La natura assume un valore se e quando è umanizzata. Il gabbiano che squarta la colomba della pace lanciata da papa Francesco dalla sua finestra, per mangiarne le interiora, non agisce né bene né male. Agisce naturalmente. E’ l’essere umano che, eventualmente, deve fare in modo di non dare in pasto ad un gabbiano un volatile che usa come simbolo di uno stato sociale che vuole instaurare. Un fiume che straripa non fa né bene, né male. Procede secondo la sua natura. E’ l’essere umano che ci si deve rapportare in modo da evitare i suoi effetti distruttivi per sé e per gli altri componenti della natura che lo circonda. Ecc., ecc.
D’altra parte, quella che definiamo come “rottura dell’unità tra l’uomo e la natura” non è un qualcosa che gli esseri umani hanno scelto di attuare. Questa specie animale ha sviluppato la capacità di appropriarsi una moltitudine di altri elementi della natura per trasformarli nelle condizioni del suo stesso processo riproduttivo. Ma per riuscire ha dovuto smettere di agire in maniera meramente istintiva, introducendo, come spiega Wittgenstein (Note sul Ramo d’oro di Fraser) una contrapposizione. Là dove questa contrapposizione non si è instaurata il problema dell’unità uomo/natura non compare, appunto perché non ci sono né un soggetto, né un oggetto, e l’attività vitale non presenta alcun grado di libertà. Ciò non toglie che molti esseri umani non sappiano nulla della natura originariamente animale dell’umanità e procedano ignorando i vincoli sottostanti ad un’evoluzione positiva della loro stessa libertà, combinando guai. Né toglie il fatto che le straordinarie forze produttive che sono state sviluppate possano operare – se non vengono coerentemente imbrigliate – in modo pesantemente distruttivo.
Per togliere questo problema non si può però fare appello all’unità immediata uomo/natura. Se il costituirsi dell’umanità è intervenuto attraverso l’elaborazione di una cultura – cioè di una forma dell’essere che media sempre l’interazione degli esseri umani con il contesto – non si può evocare un individuo in relazione immediata con il contesto naturale in cui vive senza cadere in contraddizione. Si usa infatti un’articolazione della cultura – il pensiero e la parola che attraverso di esso si esprime – per negarne il valore nel momento stesso in cui ci si avvale di essa. (Un’osservazione marginale riguarda la convinzione di Cacciari che “la separazione uomo/natura sia stata consacrata dalla rivoluzione scientifica cartesiana-newtoniana”. Da quello che so, una rozza consapevolezza di questa separazione affonda nella notte dei tempi, tant’è vero che una sua “consacrazione” è intervenuta qualche millennio fa nella stessa Bibbia.)
3.
La critica di Cacciari al mio giudizio storico positivo dei rapporti capitalistici mi fa pensare che abbiamo due concezioni profondamente diverse di ciò che chiamo “rapporti sociali di produzione”. Mi sembra cioè che egli non veda come la borghesia ha contribuito a formare la società anche per i suoi aspetti positivi. Basta riflettere un attimo su quello che lui ed io stiamo facendo: discutiamo infatti di alcune tesi che sono state formulate in parte da noi, in parte da altri, e che riguardano la natura e il senso di alcuni fenomeni sociali. Questa forma di rapporto è un prodotto dell’egemonia borghese (non il fatto che si dibatta, ma che tutti possano farlo), la quale ha sbarazzato il campo da tutte le preesistenti rappresentazioni della base della società che la facevano discendere da forze sovrastanti. Lo sviluppo della capacità di leggere e di scrivere è notoriamente un prodotto della borghesia che, proprio per sottrarre al clero il ruolo di sacro depositario del sapere, ha inventato la stampa. Ma la borghesia attua il passaggio più importante nella storia recente dell’umanità perché scopre finalmente il nesso esistente tra lavoro umano e ricchezza sociale, e crea quello che Marx chiama “il lavoro senz’altro”[4]. Il fatto che la borghesia sperimenti la sua “conquista” al contrario, e cioè abbia immaginato di aver tolto dall’individuo tutte le distorsioni e incrostazioni dei modi di produrre precedenti, riportando gli individui alla loro “naturalità”, non ci autorizza ad incorrere in un errore analogo, anche se di segno opposto, rappresentando i rapporti borghesi come distorsioni o prevaricazioni imposte ad un preesistente individuo, che immaginiamo fantasticamente depositario di un’intrinseca libertà[5].
Il fatto che i rapporti borghesi siano stati imposti con la forza non toglie che essi abbiano rappresentato un progresso. Trovo cioè che sia erroneo prospettare un’evoluzione alternativa del tutto fantasiosa, nella quale si sarebbe potuto “chiedere” alle altre classi se volessero partecipare al processo storico, come farlo o se restarne fuori. Tra l’altro, confutare che le masse subordinate, che vedevano disgregarsi i preesistenti rapporti feudali, tendessero spontaneamente “al vagabondaggio, alla mendicità e al brigantaggio”, è cosa che è stata talmente approfondita nella storia che pensavo di non doverci tornare sopra approfonditamente. E checché ne dicano alcuni studiosi marxisti è una sorta di refrain dell’analisi di Marx visto che lo si trova nell’Ideologia tedesca (p. 55) nei Grundrisse (pp. 138,442,489,511), nel Manifesto (p. 103) e nel Capitale (I, p. 785 e seg.). D’altra parte noi moderni, che facciamo un’analoga esperienza della disgregazione dei residui rapporti del passato in molte aree del mondo, con i grandi movimenti migratori attuali, non dovremmo avere difficoltà a concepire il fenomeno dell’epoca.
La transizione da una forma di vita ad un’altra, come dimostra anche la crisi che stiamo attraversando, non è mai una passeggiata, bensì poggia sulla disgregazione della forma data, che gli esseri umani possono trasformare in un modo di produzione superiore o essere travolti dalla loro stessa incapacità di afferrare la dinamica in corso.
4.
Credo che a questo punto si insinui un elemento di dissenso più sostanziale tra Cacciari e me. Lui cita Esteva per sostenere come aspetto negativo, che “il capitalismo rappresenti la storia di una guerra continua contro la produzione autonoma”. Ma la “guerra” contro la produzione autonoma è stata un processo storico sacrosantemente positivo, perché è corrisposta “allo strappare una parte notevole della popolazione dall’idiotismo della vita rurale” ripiegata su se stessa. (Il manifesto) Presa alla lettera, questa critica corrisponde ad un’apologia dell’arretratezza umana, alla negazione del fatto che tutte le capacità produttive degli esseri umani hanno un carattere necessariamente eteronomo. Come spiega egregiamente Marx nelle Tesi su Feuerbach, l’essenza umana non è un qualcosa d’innato, un dono naturale che contraddistingue la nostra specie dalle altre, bensì è “l’insieme dei loro rapporti sociali”. Cosicché solo in una relazione individuale – non autonoma! – con questi rapporti il soggetto può trovare la propria via nel percorso di costruzione dell’umanità.
Certo questo vezzo, particolarmente diffuso a sinistra, di fare appello ad una non meglio specificata autonomia, scaturisce dal bisogno della classe operaia, del tutto comprensibile, di emanciparsi dall’eteronomia capitalistica. Ma le condizioni e le capacità per realizzare quest’emancipazione non sono immediatamente date nella condizione dei lavoratori, bensì vanno sviluppate attraverso un’appropriazione di quelle forze nascoste, che sono state sin qui prodotte nella storia passata e recente, ma che debbono essere rese coerenti con lo sviluppo sollecitato da quel bisogno. Mi fa piacere qui richiamare Engels che scrive: “è assurdo parlare del principio di autorità, come d’un principio assolutamente cattivo, e del principio di autonomia come un principio assolutamente buono. L’autorità e l’autonomia sono cose relative, di cui le sfere variano nelle differenti fasi dello sviluppo sociale. Se i sostenitori dell’autonomia si limitassero a dire che l’organizzazione sociale dell’avvenire restringerà l’autonomia ai soli limiti nei quali le condizioni della produzione lo rendono inevitabile, ci si potrebbe intendere; invece essi sono ciechi per tutti i fatti che rendono necessaria la cosa, e si avventano contro la parola”.[6]
Su questo versante, ci sono poi altre due sfumature di cui tener conto.
La prima: Cacciari conviene che il modo di produzione capitalistico “abbia aumentato gli strumenti tecnici a disposizione del genere umano”. Lamenta però subito dopo che “quei benefici non sarebbero alla portata di tutti gli individui”. Ma non si può chiedere ad un sistema di rapporti sociali la capacità di trascendere i suoi stessi limiti. Spetta agli individui che sperimentano quella limitatezza come un qualcosa di anacronistico, creare le condizioni sociali del superamento di quelle relazioni. Personalmente di una cosa sono certo: senza lo sviluppo capitalistico nessuno avrebbe mai potuto seriamente immaginare “benefici diffusi a tutta l’umanità”. Ma so anche che la trasformazione di questa possibilità in realtà non è un compito del capitale, ma nostro, cioè di tutti coloro che cercare di preparare lo svolgimento di uno sviluppo alternativo. E qui ho trovato molto positivo, nello scritto di Cacciari, il riferimento ad un bisogno di continuità storica con il passato, con la radice “rossa” della possibile alternativa, che, come lui stesso ammette, viene però irriso o criticato da altri leader del movimento della decrescita.
La seconda: Cacciari mi chiede provocatoriamente se sia giusto “diminuire i flussi di materia e energia impegnati nella produzione e nel consumo, se sia giusto rispettare i cicli vitali della biosfera, se sia opportuno salvaguardare gli stock di beni naturali limitati”. Non entro in particolari. Mi limito solo a rispondere che da almeno cinquant’anni cerco di agire nel pieno rispetto di questi obiettivi, e cerco di sostenere i loro propugnatori ogni volta che essi non si collocano su un versante riflessivo che, a mio avviso, è storicamente e logicamente insostenibile. Per farla breve, la mia critica della decrescita non ha nulla a vedere con l’ipotesi “di rimanere all’interno dei rapporti capitalistici”, come teme Cacciari. Semmai il mio dissenso è relativo al fatto che con quella prospettiva non si cava un ragno dal buco e si resta intrappolati, pur senza volerlo, nei rapporti dominanti, perché non si sviluppa un sapere all’altezza del bisogno.
6.
La parte delle argomentazioni di Cacciari nella quale mi chiede di confrontarmi con lui sul “concetto di razionalità economica” soffre, secondo me, di una qualche confusione, che mi rende difficile il rispondere in modo articolato. Non so se abbia tratto da Gilbert Rist la convinzione che il concetto di sviluppo “sia nato, e sia entrato nel linguaggio economico e politico” solo recentemente. Né so se la favola che questa nascita sia avvenuta nel secondo dopoguerra negli Stati Uniti sia frutto di quello studioso[7]. So solo di aver letto decine e decine di volumi di economia dell’Ottocento e di inizio Novecento che affrontavano il problema dello sviluppo in modo chiaro e approfondito, riprendendo e sviluppando il pensiero dei pionieri del Settecento. Negli scritti di Marx il termine Etwicklung (sviluppo) si trova centinaia di volte, e le descrizioni di ciò a cui esso corrisponde sono numerosissime. Annullare tutta quella storia per ricondurla strumentalmente alle vicende ideologiche dell’imperialismo postbellico americano non è condivisibile. D’altra parte, chi ha più di sessant’anni ha vissuto nel concreto lo sviluppo, e sa bene di che cosa si sia trattato. Ed è fuori di dubbio che in esso abbia giocato un ruolo centrale anche la crescita, nonostante non abbia coinvolto tutta l’umanità.
Mi sento poi di dissentire radicalmente da Cacciari, sempre su questo aspetto, quando mi rimprovera di non tener conto che “non sono loro (i sostenitori della decrescita) a non vedere una differenza teorica tra crescita e sviluppo umano, bensì il cieco totalitarismo della ‘scienza economica’ dominante”. E poiché questa “scienza” orienta il senso comune “è inevitabile che non si faccia più distinzione tra crescita economica e sviluppo”. A mio avviso questa argomentazione svela il modo di procedere dei sostenitori della decrescita: l’opposizione non poggia su una coerente consapevolezza delle condizioni e delle possibilità date, ma si accontenta di rovesciare in toto il pensiero dominante. Sono personalmente convinto che questo approccio sia foriero di disastri, appunto perché pretende di ribaltare immediatamente il mondo, senza procedere a creare le condizioni materiali e sociali del cambiamento. Certo che la crescita non è lo sviluppo, ma è indubbio che la crescita è storicamente corrisposta ad una forma dello sviluppo. Una forma che non è nemmeno riducibile al solo orizzonte capitalista, visto che la variazione del PIL è qualcosa di profondamente diverso dalla pura e semplice variazione dell’accumulazione. (Non è questa la sede per approfondire questi problemi teorici essenziali, che i sostenitori della decrescita in genere eludono opportunisticamente). D’altra parte, il PIL come misura del livello al quale si svolge l’attività produttiva di un paese, è un prodotto del keynesismo e della transitoria conquista di un diritto al lavoro, che solo degli studiosi molto superficiali possono considerare come una pura e semplice continuazione del modo di produzione capitalistico.
Per chi conosce il concreto svolgimento della storia negli ultimi duecento anni non c’è nulla di “inevitabile” nella mancata distinzione tra crescita e sviluppo. La convinzione dell’esistenza di questo vincolo depone solo a favore di un’intrinseca debolezza della teoria della decrescita, che si sente intrappolata nel modo di pensare prevalente e pretende di riuscire a divincolarsi da esso, con lo sbarazzarsene.
7.
Come spesso succede nei confronti, ad un’apertura iniziale al dialogo, che indubbiamente caratterizza l’approccio di Cacciari, nel corso dello svolgimento del confronto la difesa prendere il sopravvento e la componente polemica finisce col sovrastare. Si può senz’altro convenire con lui che la comprensione della natura umana “nasconde ancora più di un segreto”, ma non si può accondiscendere che essa possa realizzarsi attraverso un “processo di liberazione da ogni forma di dipendenza e di eteronomia”. Se si prende l’espressione seriamente, equivale ad ipotizzare un’eliminazione della passività, che costituisce uno degli elementi intrinseci di ciò che gli esseri umani sono. Senza un adeguamento alle condizioni esteriori – sociali e materiali – del proprio essere, l’individuo si dissolve nel nulla. Se non c’è qualcuno che gli insegna a parlare non saprà mai farlo. Se non trova gli alimenti di cui ha bisogno, che non produce da solo, muore di fame. Insomma, come afferma Marx nei Manoscritti del ’44, l’essere umano è un essere passivo, e solo questa sua passività può guidarlo nella ricerca della particolare forza attraverso la quale può tendere coerentemente al suo oggetto, diventando così un soggetto corrispondente al problema evolutivo col quale si confronta. Ora, è fuori di dubbio che queste condizioni si presentino in forma dinamica, e cioè contengano degli elementi che sollecitano una trasformazione del modo di procedere. Ma non c’è nulla di più ingenuo del credere che gli elementi siano spontaneamente evidenti per gli individui, per il solo fatto di presentarsi come difficoltà che essi non riescono a tollerare.
Si fa presto a dire, citando Morin, che noi umani “siamo al 100% esseri culturali e 100% esseri naturali e al 100% razionali e al 100% sentimentali”. Se così fosse tutti i problemi storici scomparirebbero e non ci sarebbe alcun bisogno né di una teoria critica della decrescita, né di altre teorie che spingono per il cambiamento. Purtroppo il nesso tra la componente naturale dell’uomo e la componente culturale è molto più complesso e finora si è svolto in forma prevalentemente oppositiva. Non a caso quando Darwin ha evidenziato la specifica origine naturale dell’essere umano c’è stata una levata di scudi generale contro di lui, e anche oggi il suo insegnamento non è realmente penetrato nel senso che guida i comportamenti quotidiani. La tesi richiamata da Cacciari serve ai sostenitori della decrescita per far credere che il compito con il quale dobbiamo confrontarci sia molto più facile di come in realtà è, perché si tratterebbe soltanto di restaurare una fisiologia che sarebbe stata violata. Una semplificazione che è ben espressa anche dalla convinzione che “nella coscienza e nella mente e nel cuore e nel cervello di ognuno sia iscritta la capacità di distinguere il bene dal male”. Personalmente aderisco ad un approccio ben diverso. A mio avviso gli esseri umani non sanno a priori ciò che è bene e ciò che è male, e debbono ogni volta impararlo nell’interazione pratica con il mondo che hanno ereditato e che contribuiscono a riprodurre o a distruggere più o meno consapevolmente. Il confine tra il bene e il male cambia così in continuazione, non può essere deciso una volta per tutte, e tanto meno può essere iscritto in una soggettività che è necessariamente in continua evoluzione per interagire coerentemente con il suo oggetto, cioè il mondo naturale e la società. (Per questo non concordo proprio con l’ipotesi di Cacciari di una continuità storica tra la “nuova frontiera kennedyana e il neoliberismo thatcheriano-reaganiano che hanno rappresentato un rovesciamento della prima. Basta rileggere i suoi programmi e i suoi discorsi per rendersi conto che, seppure con ingenuità, Kennedy cercava di emulare il Welfare europeo attraverso un imbrigliamento delle forze del mercato. Reagan rappresentò, invece, una reazione oppositiva ai residui di quel progetto sociale.)
8.
E’ bene soffermarsi brevemente sullo stravolgimento metodologico che deriva dall’approccio che ho criticato nel punto precedente. Per Cacciari l’economia politica al suo nascere avrebbe “decretato (?) per l’essere umano uno statuto esclusivamente e necessariamente egoista e individualista”. Ma qui si salta a piè pari la realtà sociale nella quale quella forma di sapere ha originariamente preso corpo. Non dimentichiamolo, siamo nella seconda metà del Settecento. La stragrande maggioranza dell’umanità vive attraverso forme produttive ereditate, che ancora debbono avvalersi delle conquiste scientifiche in corso, in molti paesi sussiste ancora l’istituto della schiavitù, e, soprattutto, i nuclei sociali sono relegati a livelli locali estremamente ristretti e con esigui contatti con altre realtà umane. L’economia classica, della quale lo stesso Marx riconobbe il carattere scientifico, individua nel rapporto di scambio la mediazione per porre fine o ridimensionare quel drammatico isolamento reciproco, e dà una base a quella che diventerà la rivendicazione politica principale dell’epoca: basta con la subordinazione personale, avanti con la libertà individuale, perché ognuno deve poter produrre senza sottostare ad una costrizione personale altrui! Cercando di arricchire se stessi attraverso la produzione per altri, gli individui creano involontariamente le condizioni per l’arricchimento anche di questi altri, perché li sollecitano a entrare in un processo riproduttivo comune. Insomma, in parallelo con la conquista dell’indipendenza personale reciproca, si creano le condizioni di una dipendenza materiale degli uni dagli altri, cioè di una produzione a carattere universale. Perché rimuovere questo aspetto storico positivo dei rapporti borghesi? Perché immaginare che gli esseri umani fossero in grado di conquistare l’universalità dei loro rapporti a prescindere dallo sviluppo capitalistico? Perché immaginare, cioè, che l’egemonia borghesia non sia stata altro che un arbitrio?
Certo poi, con l’ulteriore sviluppo sono emersi dei problemi. Mentre i lavoratori agivano in modo da sottostare al rapporto di scambio solo per riprodurre se stessi nelle condizioni date – è la critica che Marx avanza nei confronti del lavoro salariato – i capitalisti agivano in modo da procedere soltanto a quelle produzioni che avrebbero fatto crescere la loro ricchezza. Né gli uni, né gli altri affrontavano il problema di come si potesse garantire nel concreto l’arricchimento di tutti. Ma l’indifferenza reciproca, insita nel rapporto di scambio, non costituisce un degrado rispetto alla situazione preesistente, perché quegli individui che entrano in contatto reciproco attraverso lo scambio, o non si conoscevano nemmeno o erano nemici. Lo scambio corrisponde così all’instaurarsi di un timido nesso tra individui che non sentivano di appartenere alla stessa specie. Attraverso lo scambio essi certamente non giungevano a riconoscere quest’appartenenza, ma grazie ad esso instauravano una delle condizioni per procedere in quella direzione, corrispondente al fatto che i prodotti altrui potevano essere beni, cioè oggetti che potevano soddisfare bisogni entrando nel proprio processo riproduttivo senza violenza. (Credo che le pagine che Marx dedica a questo aspetto dello sviluppo nei Grundrisse PP. 207/221, siano estremamente illuminanti.)
9.
Veniamo ora a quello che può essere considerato il clou dell’intera controversia. La critica che sviluppo nei confronti dell’ipotesi della decrescita (e di altri movimenti) riguarda il modo in cui i suoi sostenitori pretendono di interpretate e di affrontare i problemi che hanno investito la nostra società. Quando Cacciari afferma che dovremmo batterci perché “la costruzione storica cui è giunta l’umanità” non gli piace, rivela il limite metodologico comune alla maggior parte dei teorici della decrescita, che consiste nel proiettare nel contesto una libertà che non è data. Libertà che si immagina sia esistita nel dar corpo alla formazione sociale esistente, libertà che si immagina esista per procedere alla sua trasformazione.
La mia formazione mi impedisce di convenire con quest’approccio, che secondo me contrasta con l’accettazione del principio di realtà. Ciò che ostacola l’instaurarsi di una corrispondenza tra il bisogno e quello che possiamo considerare come il suo oggetto, cioè l’effetto sperato. Per non dilungarmi riassumo la questione con le parole di Marx. “Nell’esame delle condizioni politiche”, scrive (Giustificazione del corrispondente dalla Mosella 1843), “si è cercato con troppa leggerezza di non tener conto della natura oggettiva delle situazioni e di far tutto dipendere dalla volontà delle persone agenti. Ma si danno situazioni che determinano tanto le azioni dei privati quanto delle singole autorità, eppure sono indipendenti da esse quanto il sistema respiratorio. Se fin dall’inizio ci si pone da questo punto di vista oggettivo, non si riesce ad addossare in maniera prevalente la buona o la cattiva volontà né all’una, né all’altra parte, ma si vedranno agire situazioni dove di primo acchito sembrava agissero solo persone. Non appena si sia dimostrato che una certa cosa viene resa necessaria dall’insieme della situazione, non sarà difficile determinare sotto quali condizioni esteriori questa cosa abbia dovuto realmente entrare a far parte della vita e sotto quali condizioni, sebbene già ne preesistesse il bisogno, non abbia potuto entrarvi”.
Questo metodo costringe a procedere nella riflessione e nella formulazione delle proposto tenendo continuamente conto non solo dei presupposti naturali noti, ma anche dei presupposti storici e di quelli logici. Poiché il rispetto di questi vincoli causa una frustrazione in coloro che pretendono di sentirsi immediatamente depositari del potere che cercano di far valere, i miei rimandi a quei presupposti li infastidiscono. Lo stesso Cacciari, nonostante si impegni in un equilibrato tentativo di rispondere alle mie argomentazioni, nella parte finale del suo scritto si fa prendere la mano. Riassumiamo le obiezioni.
Sbaglierei nel sottolineare che oggi in Europa il rapporto salariato è considerato come la forma normale di partecipazione al processo produttivo. Ma a me sembra solo di constatare un fatto dal quale non si può prescindere.
Sbaglierei nell’insistere che “non ci sono alternative già pronte” e nell’aggiungere che affinché ci sia una speranza di ottenere i cambiamenti necessari, si deve innanzi tutto individuare il punto di partenza, prepararne la situazione, crearne le condizioni. Anche qui credo di limitarmi a constatare una situazione data.
Sbaglierei nel presumere che, siccome la crisi, nei paesi sviluppati, si concretizza nell’impossibilità di riprodurre il rapporto salariato nella misura necessaria a garantire il pieno impiego, sia nel rapporto col capitale, sia nel rapporto con lo stato, da lì si debba partire per conquistare quel punto di partenza. Sono senz’altro convinto che la forza degli individui possa prendere corpo e svilupparsi solo partendo dall’esperienza dell’insostenibilità della loro stessa condizione.
Sbaglierei nell’evocare, non già il Keynes che si batteva per un massiccio intervento dello stato in una politica del pieno impiego, ma quel Keynes che anticipava consapevolmente quelli che sarebbero stati i limiti di quella strategia, indicando anche come affrontare quella difficoltà di riprodurre il lavoro salariato. Ma molti dei sostenitori della decrescita ignorano completamente questa parte del pensiero keynesiano.
Sbaglierei nel considerare il rapporto di classe come un’anacronistica palla al piede, che impedisce la formazione dell’individuo socialmente consapevole, perché quest’individuo, nella fantasia dei sostenitori della decrescita, sarebbe già all’opera. Confesso che mentre incontro e ho incontrato soggetti che agivano come membri di classi sociali non ho mai avuto l’onore di incontrare individui che avessero già sviluppato una consapevolezza sociale della natura della crisi.
Sbaglierei, infine, nel sottovalutare la gravità della crisi della quale non riconoscere la natura “multidimensionale e sistemica”. Purtroppo quasi tutti i miei scritti degli ultimi vent’anni sono dedicati a questo problema.
Per sottolineare l’inaccettabilità di questi miei errori, Cacciari evoca una sventagliata di studi che prospettano, sotto nomi diversi, il bisogno di un’alternativa sociale. Qui però c’è un evidente fraintendimento. La mia critica non riguarda l’esistenza o meno di questo bisogno, quanto piuttosto la forma in cui esso cerca di esprimersi. Venti nomi, venti prospettive, non sono meglio di una, e se si sommano nelle intenzioni, bisogna sempre valutare se l’energia di ognuna non sia tale da elidere quella delle altre, proprio perché, come accade in molti sostenitori della decrescita (e di altri movimenti), ciascuna pretende di rappresentare l’unico vero universale.
Cacciari, criticandomi, ha dimostrato di non cadere in questa trappola, e di questo gli sono grato. Ma il cammino è lungo, e i rovi che lo ostacolano sono ancora là di fronte a noi.
[1] Un confronto utile c’è stato anche con Marino Badiale, col quale spero di approfondire ulteriormente i motivi di dissenso.
[2] La tesi dell’ultraconservatore Milton Friedman è infatti che gli esseri umani siano “liberi di scegliere”.
[3] Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La Nuova Italia, Firenze 1970, vol. I,p.101.
[4] Introduzione del ’57, in Lineamenti cit. pp.31/32.
[5] E’ l’errore in cui cade, purtroppo, Claudio Napoleoni che è senz’altro il migliore studioso di Marx che abbiamo avuto in Italia.
[6] In Marxismo e anarchismo. Editori Riuniti
[7] Ma Pallante la ripete in continuità.